 Le navi di Nemi
Le navi di Nemi di Marina e Massimo
Medici
Per gentile concessione di Controluce
Che strano destino quello delle due navi romane:
per poco tempo hanno galleggiato sul lago di Nemi. Per due millenni hanno
dormito in fondo al lago e, se vi fossero rimaste ancora per qualche anno,
non sarebbero state divorate dalle fiamme.
Nessun autore dell’antica Roma ne ha mai parlato.
Se ne conosceva (anzi se ne supponeva) l’esistenza solo perché
i pescatori, già dal Medioevo, di tanto in tanto, oltre ai pesci,
portavano alla superficie numerosi reperti archeologici che provavano
come qualcosa d’antico e di bello giacesse in fondo al lago. Ma di
che cosa si trattasse esattamente nessuno lo sapeva; così la fantasia
poteva correre a briglia sciolta; e si cominciò a pensare, a sperare
in tesori nascosti, mentre ogni volta che le reti strappavano dal fondo
qualche cosa era la prova che… qualcosa vi fosse.
Passarono i secoli e di tanto in tanto qualcuno provava a carpire, alle
acque, il loro segreto; ma i tentativi erano volti solo ad assicurarsi
cimeli e a strappare quelle opere d’arte che potevano impigliarsi
nelle reti, senza quindi quello spirito di ricerca scientifica che deve
caratterizzare una campagna di recupero archeologico.
Peraltro va detto che nei secoli passati non esisteva quello spirito,
ma solo l’iniziativa dei singoli che, nella più completa libertà
d’azione e senza nessun controllo da parte dello Stato, potevano
prelevare (ma sarebbe meglio dire saccheggiare) tutto ciò che apparteneva
al passato. Questo, che a noi moderni sembra assurdo, è accaduto
non solo in tutto il Medioevo, ma in tempi quasi contemporanei. Basti
pensare che i Papi, molte volte, smantellavano meravigliose opere dell’antica
Roma per farne mattoni.
Lo stesso Colosseo, il più grande monumento di Roma, non sfuggì
a questa sorte. Gli furono tolti i marmi che ne ricoprivano le pareti,
e oggi possiamo ammirare solo i fori in cui erano inseriti i loro supporti.
Se ne cominciò la demolizione per costruire, con le sue pietre,
altri monumenti e chiese che potessero sostituirsi a quelle erette in
onore degli dèi "falsi e bugiardi".
E pensare che Roma, nella sua grandezza, accoglieva e onorava tutti gli
dèi che erano venerati dai popoli con i quali veniva in contatto.
Basti menzionare il Pantheon nel quale ogni divinità aveva il suo
altare. Ma Roma era grande; abbracciava col suo spirito tutto il mondo
allora conosciuto e il suo orizzonte era degno del suo spirito. Questo
breve tuffo nei secoli passati che non si curavano dell’antica grandezza
di Roma, è stato necessario per sottolineare come, per tanto tempo,
delle Navi di Nemi non ci si fosse occupati per nulla.
Ad onor del vero, va anche detto che non c’erano, allora, i mezzi
tecnici per raggiungere quelle imbarcazioni che riposavano sul fondo del
lago. Qualche raro tentativo si fece, anche se non si aveva la certezza
di cosa vi fosse esattamente nelle profondità delle acque, mentre
i racconti delle genti che vivevano intorno a quello specchio d’acqua
continuavano a mantener vivo l’interesse sui segreti custoditi dal
lago.
E venne il tempo in cui alcuni spiriti colti e amanti dell’arte
ascoltarono con interesse quei racconti, esaminarono con attenzione gli
oggetti che tornavano alla luce del sole dopo tanti secoli d’oblio
e si adoperarono a restituire a tale luce quelli che ne erano privi. Nelle
prossime pagine parleremo del motivo per il quale quelle navi furono costruite,
dell’uso che se ne fece e di chi le volle. Del perché, dopo
pochi anni, andarono perdute e di cosa vi fosse su di loro e perché
fossero collegate al santuario di Diana Nemorense.
Dei tentativi di recupero che furono fatti nei secoli da eminenti personaggi
fino a quello definitivo, raggiunto con mezzi d’avanguardia, e seguito
purtroppo, a brevissimo tempo, dalla loro distruzione. Esaminando quei
ritrovati tecnici connessi all’arte nautica che, conosciuti dai romani,
dimenticati per tutto il Medioevo, riscoperti ai nostri tempi e usati
con orgoglio dalle marine moderne, ci si avvede come già facessero
parte del bagaglio culturale e tecnico di Roma.
Parleremo delle moderne àncore di duemila anni fa; delle piattaforme
rotanti su cuscinetti a sfere conosciute e usate, poi dimenticate e…
riscoperte; della tecnica nella costruzione dello scafo, del suo calafataggio
ottenuto usando speciali materiali tipici delle navi marine e adoperati
per le navi lacustri che hanno esigenze diverse. Diremo dei diversi tipi
di chiodi e della particolare tecnica del loro uso marinaro. Per ultimo,
del Museo delle Navi, di ciò che contiene, di quello che è
stato portato altrove in vari musei e anche in case patrizie; e ancora
di quello che ci si sta proponendo di fare per trasmettere alle future
generazioni la nozione e il ricordo degli sforzi che sono stati fatti
nel recupero che fu definito l’avventura archeologica più
entusiasmante di tutti i tempi. Sappiamo che nessun autore classico
ha parlato delle navi, ma già nell’alto Medioevo gli abitanti
di Nemi sapevano dell’esistenza di qualcosa di molto particolare
nelle acque del lago. Un’antica città sommersa? Tesori? Ricchezze?
Solo quando iniziarono precise ricerche, a partire dal XV secolo, si capì
che si trattava di imbarcazioni. Due navi antichissime cominciarono
allora lentamente ad avvicinarsi, ancora avvolte nelle nebbie dei secoli.
Se ne scorgevano appena i contorni che grondavano d’acqua e di storia.
I ponti, deserti, erano affollati di fantasmi. Ora noi moderni possiamo
rispondere finalmente alla prima domanda: chi le volle? Si sono fatte
mille ipotesi su chi potesse essere il personaggio, certamente ricco e
potente, che ne ordinò la costruzione. Si fecero vari nomi, ma
la certezza si raggiunse solo quando, fra i numerosi reperti che si trassero
dalle acque, comparvero le così dette fistulae acquariae.
Sono esse delle grosse tubazioni in piombo che facevano parte di un impianto
idraulico alla portata delle possibilità economiche di persone
particolarmente ricche e potenti. Portavano l’acqua corrente sino
all’interno dei loro palazzi. Convogliandola, poi, in altre fistule
plumbee, veniva utilizzata come acqua potabile e per alimentare le fontane
che abbellivano le case dei romani doviziosi. Questi tubi erano ricavati
da lastre rettangolari di piombo saldato longitudinalmente e si era soliti
stampigliare su di essi il nome del proprietario, spesso il nome del "liberto
idraulico" e a volte il numero progressivo. Fu così che
si risalì all’identità di chi le volle: l’imperatore
Caligola. Egli non desiderò due navi qualsiasi, ma con una particolarità
peculiare: dovevano essere portatrici di costruzioni di tipo terrestre,
con terme e templi coperti da tegole in terracotta oppure in bronzo ricoperte
da una patina d’oro. E poi colonne di varia grandezza e foggia, pavimenti
in mosaico, statue e altre opere in bronzo finemente lavorato, e ancora
statue, protomi leonine, ghiere per i timoni e tante, tante cose ancora…
Fra queste, come abbiamo visto, anche le fistule plumbee che assicuravano
il rifornimento idrico, partendo dalle rive del lago e arrivando fino
alle navi, a tutte le numerose persone che si accompagnavano all’imperatore
su quelle: ospiti illustri, dignitari, musici, soldati, amici e…
nemici, vista la fine che fecero Caligola e le sue navi. Ma chi avrebbe
mai desiderato due navi per innalzarci sopra costruzioni di tipo terrestre?
E per farci cosa, visto che grandi e lunghi viaggi non se ne possono fare
in un piccolo lago come quello di Nemi? Insomma. Caligola, chi era
costui? Cominciamo dal nome, anzi dal soprannome. Lo chiamarono così
i legionari romani con i quali visse per lunghi anni fin da bambino, seguendo
il padre nelle guerre contro i Germani. Lo chiamarono così perché
Caio Giulio (era questo il suo nome) soleva portare le calzature militari
dette caligae; il suo soprannome voleva quindi dire "piccola
scarpa". Nacque ad Anzio nel 12 d.C. L’imperatore Tiberio,
successore di Augusto, lo adottò come nipote e lo designò
suo erede. Il Senato accettò di buon grado la sua candidatura e
lo elesse imperatore nell’anno 37, quando aveva solo 25 anni ed era
un giovane che sembrava pieno di energia e di spirito intraprendente.
Ma c’era una ragione per cui i senatori lo elessero volentieri: speravano
che avrebbe interrotto la politica di Tiberio che aveva cercato di mettere
da parte il Senato nella conduzione dello Stato. Egli deluse queste aspettative
e, forse, furono proprio i senatori che descrissero e fecero descrivere
il principato di Caligola come una lunga, unica, continua pazzia, che
si sarebbe manifestata attraverso manie di assolutismo e di persecuzione.
Passò alla storia come un uomo che infierì sui propri parenti,
fece uccidere grandi dignitari dell’impero, volle farsi adorare come
dio, compì stranezze e crudeltà di ogni genere e, infine,
nominò senatore il proprio cavallo! Inoltre fu sospettato di avere
rapporti incestuosi con sua sorella Drusilla, che divinizzò dopo
la morte. Avrebbe voluto erigere una sua statua nel Tempio di Gerusalemme,
ma incontrò forti opposizioni e dovette desistere dal proposito.
Fu responsabile di gravi disordini tra gli Ebrei ad Alessandria e in Giudea.
Tutto questo non gli impediva di coltivare uno sfrenato amore per il lusso
e di creare, intorno alla sua persona divinizzata, una fastosissima corte
da monarca orientale. Invero ci fu anche del buono: appena nominato
imperatore, limitò, continuando la politica di Tiberio, i poteri
del Senato e si appoggiò al popolo, al quale ridusse le imposte,
fece elargizioni e concesse amnistie, e restituì l’antica
autorità ai Comizi centuriati e ai tribuni. Volle, cioè,
che i Romani si riappropriassero di quegli strumenti amministrativi del
passato gestiti direttamente dal popolo, che avevano fatto grande Roma
attraverso, appunto, l’esercizio del potere da parte dei cittadini.
Ma questi orientamenti furono solo iniziali, poiché Caligola
mirò alla deificazione dell’imperatore da vivo, pretese quindi
onori divini e aumentò ancor di più il fasto della sua corte.
Detto questo, forse, riusciremo a comprendere il perché delle due
navi. Lo sfarzo esagerato in cui viveva però costava molto
e Caligola fu costretto a imporre nuovi tributi per far fronte alle spese.
In tal modo, come era prevedibile, perse il favore del popolo. Inoltre
il suo potere e la sua autorità diminuirono in conseguenza di due
spedizioni militari particolarmente infruttuose: una in Britannia e l’altra
in Germania. Divenne molto sospettoso e inutilmente crudele, finché,
anche a causa della sua dissolutezza, fu ucciso in una congiura di senatori
e cavalieri organizzata dal tribuno Cassio Cherea. Era il 24 gennaio dell’anno
41 e con lui, nel palazzo, trovarono la morte la sua quarta moglie e la
sua unica figlia. V’era una consuetudine nel mondo antico romano:
la damnatio memoriae, cioè la distruzione di ciò
che una persona, particolarmente odiata, aveva fatto in vita. Essa faceva
parte delle pene che colpivano la maiestas e prevedeva che il praenomen
del condannato non si tramandasse in seno alla sua famiglia, che le sue
immagini venissero distrutte e il suo nome cancellato dalle iscrizioni.
Anche Nerone e Didio Giuliano vennero chiamati hostes, cioè
nemici, e condannati dal Senato. In altri casi, invece, i senatori votarono
una damnatio memoriae postuma che comprendeva anche la rescissio
actorum. Roma, grande e terribile: come le sue leggi! Esse sapevano
trasformare un nemico vinto in uno schiavo; uno schiavo, se uomo di valore,
in liberto; un liberto, se uomo di cultura, in precettore; un generale,
se valoroso, in imperatore, come accadde a Diocleziano, che era addirittura
figlio di un liberto. L’Urbe sapeva, quindi, innalzare alle supreme
vette dello Stato un cittadino fino a farne un dio, se meritevole, ma
sapeva anche precipitarlo nell’abisso del nulla. Nel caso della damnatio
memoriae le leggi di Roma tendevano a cancellare addirittura lo stesso
nome e financo il ricordo d’un cattivo cittadino. E se esse lo colpivano
quando era ancora vivo, venivano a creare, dal punto di vista giuridico,
una sorta di morte civile. Era quello che il Romano antico temeva
di più d’ogni cosa: non fare più parte dell’Urbe,
pur essendo ancora vivo. Non poter più dire: "Noli me tangere,
civis romanus sum" e incutere, con queste parole, un immenso
rispetto e timore intorno a sé. Era come la morte; era più
della morte. Le due navi di Nemi erano state volute da Caligola, e
quando questi fu ucciso, nell’anno 41, furono affondate con tutto
quello che contenevano. Il lago inghiottì un’opera unica
e lussuosa che giacque per due millenni sul fondo. Nessuno mai ne scrisse
una parola, e su di esse scese l’oblio. Solo qualche pescatore, di
tanto in tanto, traendo dalle acque le reti, strappava dall’abisso
e riportava alla luce qualcosa che sembrava appartenere a un altro mondo
lontano. Ne nacque una leggenda.
I primi due tentativi di recupero
Abbiamo scoperto colui che volle due navi nel lago di Nemi. L’uso
che Caligola ne fece, però, dobbiamo desumerlo studiando il personaggio,
osservando attentamente come erano costruite e cosa vi fosse sopra le
due navi; quali reperti tornarono alla luce ed a che cosa potessero servire;
quali riti e credenze religiose vi fossero all’epoca. Tutto questo
poiché mancano completamente scritti di storici, canti di poeti
o libri di scrittori classici che parlino dell’argomento. Dell’Imperatore
abbiamo già parlato nel capitolo precedente: della sua personalità,
delle sue manie di assolutismo, delle stranezze e crudeltà che
ci tramanda la storia. Continuiamo, allora, con i tentativi di recupero
che si fecero nei secoli passati. Così, attraverso lo studio dei
reperti che si riuscì più o meno maldestramente a strappare
al lago, fino al recupero completo delle due imbarcazioni, potremo, forse,
risalire al pensiero di Caligola come si farebbe con i pezzi di un mosaico
che si volessero rimettere al loro posto, gli uni accanto agli altri,
per ottenere di nuovo l’intera opera d’arte. Il primo di
questi tentativi lo dobbiamo al cardinale Prospero Colonna nell’anno
1446. Questo prelato, signore delle terre di Nemi e del lago, uomo di
vasta erudizione e, come tutti gli studiosi del tempo, entusiasta di quanto
poteva riferirsi alle glorie di Roma antica, avuta cognizione delle voci
dell’esistenza delle navi, volle tentare di riportarle a galla. Nonostante
non si fosse ancora in possesso di mezzi tecnici idonei al recupero di
navi affondate, affidò il difficile compito a Leon Battista Alberti.
Questi non solo aveva giusta fama come umanista e letterato, ma era anche
considerato fra i più esperti ingegneri idraulici del suo tempo.
A Leon Battista Alberti Roma deve essere particolarmente grata per aver
sapientemente restaurato e riattivato, per ordine di Nicolò V°,
l’acquedotto detto dell’Acqua Virgo e di Trevi. Ma parlare dell’Alberti
senza fare almeno un accenno all’attività multiforme del massimo
esponente della cultura umanistica è impossibile. Con lui l’arte
diventa l’asse del nuovo sistema culturale e assume valore di dottrina
autonoma ed egemone, ponendosi come concezione del mondo. I suoi tre trattati
della pittura, della scultura e dell’architettura costituiscono una
completa teoria dell’arte. Quanto all’architettura, egli è
il primo architetto che valuti, anche dal punto di vista psicologico,
il trapasso emozionale dalla luminosità e dalla concretezza volumetrica
dell’esterno alla penombra ed alla cavità dell’interno.
Tra gli altri capolavori, progetta una facciata anche per la chiesa gotica
di Santa Maria Novella; ma non dobbiamo dimenticare il Palazzo Rucellai
a Firenze. Fissa, in questo caso, il tipo del palazzo signorile che, come
dichiara nel "Trattato", deve imporsi più con il prestigio
intellettuale delle proporzioni che con l’ostentazione del fasto
e della forza. Per Mantova l’Alberti progetta le chiese di S.Sebastiano
e di S.Andrea. Questi era l’artista a cui il cardinale Colonna affidò
l’arduo incarico. Le operazioni di recupero delle navi ebbero
inizio e furono descritte da Flavio Biondo da Forlì, altro dotto
umanista, storico, segretario di quattro pontefici, autore di una "Storia
d’Italia del Medioevo" e di una "Italia illustrata"
nella quale, appunto, ritroviamo il resoconto delle operazioni dell’Alberti.
È da rilevare che, con curioso epiteto, le navi vengono chiamate
"annegate". Come s’è detto in quel tempo non si
disponeva di adeguati mezzi tecnici atti alla bisogna, e Leon Battista
Alberti chiamò alcuni valenti nuotatori genovesi, i famosi marangoni,
che oltre ad essere esperti del nuoto, dovevano avere una buona dose di
coraggio. Dico questo perché, senza le maschere da sub moderne,
cioè immergendosi con l’acqua che tocca direttamente il bulbo
oculare, si ha una sensazione di effetto nebbia. Tale effetto non fa percepire
con nitidezza l’ambiente circostante ed andando sempre più
a fondo si ha l’impressione, mancando quasi del tutto la visibilità,
di penetrare in un ambiente ostile senza sapere cosa c’è dopo.
Ora, i marangoni, andando sotto senza maschera, naturalmente in
apnea, vedendo poco e niente né lateralmente, né soprattutto
al di sotto, si avvicinavano ad una "cosa" ancora non conosciuta,
misteriosa e forse ostile, piena di storia e di antiche leggende…
dovevano avere certo un bel coraggio. Essi raggiunsero e, per quanto fu
loro possibile, esplorarono la nave più vicina alla riva che era
adagiata sul fondo del lago e ne riferirono la distanza e la profondità.
Si costruì una piattaforma galleggiante e con delle corde munite
di ganci, si tentò di tirare la nave a riva. Si riuscì invece
solo a strappare un pezzo dell’imbarcazione, e insomma il risultato
fu semplicemente disastroso: non solo la nave nel suo insieme non si mosse
ma, privata di una parte importante della sua struttura, fu seriamente
danneggiata. Tuttavia molti personaggi della Corte di Roma che seguivano
i lavori dalla riva del lago si affollarono ad ammirare quel frammento
dell’antica Roma che tornava alla luce del sole. Poi fu portato trionfalmente
nell’Urbe perché fosse ammirato da Nicolò V°,
valoroso promotore del Rinascimento umanistico. Passati alcuni anni, però,
non si ebbe più notizia di che fine avesse fatto il reperto; tuttavia
questo episodio ebbe il merito di accendere il fuoco del desiderio di
ricerca e di studio. Il secondo tentativo, non meno rovinoso del precedente,
lo dobbiamo a Francesco De Marchi nel 1535. È passato quasi un
secolo. Il tentativo è documentato da un resoconto sulla nave più
tecnicamente preciso. Il De Marchi, che era allo speciale servizio di
Alessandro de’ Medici, Duca di Toscana, oltre ad essere un erudito
aveva fama di essere un celebre architetto meccanico specialmente dedito
ad opere di carattere militare. Era autore di un trattato di "Architettura
militare", nel quale è data ampia notizia del suo tentativo.
Contrariamente a chi lo aveva preceduto non delega ad altri l’esplorazione
del lago, ma si immerge personalmente varie volte avvalendosi di una specie
di "campana" inventata da Guglielmo di Lorena, che partecipa
anch’egli alle immersioni. Come si vede non è passato del
tutto un secolo e già c’è un notevole progresso…
di mezzi tecnici subacquei: dalle braccia dei nuotatori ad una campana
per l’esplorazione sott’acqua. De Marchi stesso ce lo descrive
in un suo scritto. L’istrumento era fatto di legno ed aveva
la forma di una campana le cui parti erano tenute l’una stretta all’altra
per mezzo di alcuni cerchi di ferro. Avevano un tondo di vetro sul davanti
per vedere di fuori, mentre l’esploratore poteva entrarvi fino alla
metà del corpo avendo braccia e gambe libere. L’aria poteva
entrare nella campana e probabilmente poteva uscirne, ma per mezzo di
un altro tubo. In ogni caso l’esatta tecnica del ricambio dell’aria
non si conosce, anzi, Guglielmo di Lorena fece giurare al De Marchi che
mai avrebbe descritto quale fosse il marchingegno che permetteva tale
ricambio. Entrambi mantennero il segreto e nulla si sa di più sull’argomento.
Dell’impenetrabile Mastro Guglielmo, il De Marchi ci ha lasciato
questo curioso ritratto: "Era homo di grandissima barba e folta
e li passava la cintura mezzo palmo e se ne faceva le trezze intorno al
capo, ma era homo di grande ingegno". Il resoconto dell’allora
trentunenne esploratore prosegue, e ci narra che il giorno 15 luglio 1535
si immerse nelle acque del lago. La luce, data la profondità, era
scarsa e la visibilità non era molta a causa della poca trasparenza
delle acque. Si era denudato dalla cintola in giù poiché
temeva che i panni si sarebbero potuti impigliare in qualche roccia rendendogli
difficile, o addirittura impossibile, il ritorno in superficie. Attraverso
quel vetro, tutto ciò che vedeva gli sembrava molto più
grande, anche i pesci latterini, che invece sono molto piccoli. Ebbe,
forse, quel tuffo al cuore che prende tutti i subacquei moderni alla prima
immersione: i pesci appaiono grandissimi… molto più di quanto
lo siano fuori dall’acqua. Cominciò ad osservare la nave più
vicina alla riva, che era anche quella che giaceva a minor profondità.
Si spostava lentamente sott’acqua camminando sullo scafo, e poté
vedere che era molto grande. La lunghezza secondo la sua valutazione era
di sessantaquattro metri e la larghezza di venti. Una nave molto grande,
sia per i tempi che per il sito dove si trovava. Il legno, protetto dal
fango, era ben conservato anche se aveva quasi duemila anni. Era coperta
parzialmente dalla melma del lago, si intravedeva la ruota e parte della
poppa, si intravedevano gli scalmi; molti erano i danni provocati dai
tentativi di recupero precedenti. L’unica nota vivace di quest’avventura
è che i latterini che popolano il lago, poiché l’esploratore,
come abbiamo detto, si era immerso nudo al di sotto della cintola, gli
andavano a mordicchiare in quelle parti del corpo che ognuno può
comprendere, nonostante il De Marchi cercasse di allontanarli con le mani.
Ma sentiamo le sue stesse parole: "... mi cingevano intorno dove
io ero senza braghe e mi andavano a piccare e io con le mani li dava,
ma non curavano nulla, come quelli che erano in casa loro". Corse
quindi ai ripari; si mise i calzoni e dopo essersi rituffato più
volte cercò di cingere la nave con fasce e cordami, nella speranza,
con lo sforzo di molti argani, di poterla strappare dal fango e riportarla
in superficie. Tutto fu inutile. Le corde si ruppero; quanto a lui, lo
sforzo gli provocò un’emorragia dalla bocca e dal naso finché,
risalito in superficie, si accorse che il suo giubbone bianco era tutto
rosso di sangue. L’avventura era finita nonostante la volontà
e il coraggio. E di questo si trattava e noi moderni, per rendercene conto
appieno, dobbiamo immaginarci uomini del secolo XVI, ancora all’inizio
delle grandi scoperte scientifiche, illuminati solo dalla luce del Rinascimento,
rischiararsi di quello ed inoltrarsi verso il buio dell’ignoto. Era
pari, quell’avventura, alle esplorazioni dello spazio che furono
effettuate secoli e secoli dopo. In quella, come queste, l’uomo si
lanciava in un elemento che non era il suo, vincendo la propria legittima
paura dell’ignoto, tagliandosi dietro di sé molte delle possibilità
di rientro in caso che l’esplorazione fallisse
Il terzo tentativo di recupero.
Dai primi due tentativi di recupero delle navi passarono
quasi tre secoli prima che qualcun altro ne tentasse un terzo. E fu una
vera fortuna, visti gli scarsi mezzi tecnici usati fino ad allora ed ancora
i soli ad essere a disposizione - salvo una lodevole buona volontà
che, però, non poteva certamente sostituirli. In ogni caso
quel gran darsi da fare intorno, sopra e sotto il lago di Nemi aveva risvegliato
l’interesse dei ceti più colti del tempo, che furono vieppiù
invogliati al recupero delle navi, a quello che v’era sopra e a quello
che si supponeva vi fosse dentro. Si era sicuri, ormai, che si trattasse
di due imbarcazioni. Si era certi che vi fossero sopra delle costruzioni
di tipo terrestre, come edifici, colonne, statue, addirittura pareti e
pavimenti in marmo pregiato e mosaici finemente lavorati. Così
la fantasia riprese a correre favoleggiando di tesori sommersi, di monete
d’oro e di monili preziosi. Se la parte più dotta della
popolazione di quei tempi pensava di riscoprire un po’ della storia
romana, quella meno dotta pensò di recuperare la parte più...
preziosa, se ve ne fosse. Così i pescatori del lago, che ormai
avevano visto qual era il luogo esatto dove erano sommerse le navi ed
avevano visto che non era impossibile raggiungerle, superate tutte le
paure, cominciarono, anzi continuarono con più lena di prima la
loro spoliazione. Questa fu documentata anche dalla cronaca di Padre Casimiro
che ne parla nelle sue "Memorie sui conventi francescani" nella
seconda metà del Settecento. Il religioso dice di legnami, grossi
chiodi di rame, lamiere di piombo, tegole di rame, cose tutte che sono
continuamente strappate alle navi, che subiscono così più
danni dalle rapine degli uomini che dalle ingiurie del tempo. Tuttavia,
pur essendo uomo colto, il Padre Casimiro incorre in grosse inesattezze,
alimentate probabilmente sia da tutte le dicerie e racconti fantasiosi
che si facevano sull’argomento, sia anche dal desiderio e dal piacere
di fare asserzioni più o meno dotte sebbene in mancanza di elementi
certi. Ma facciamo parlare l’autore stesso delle memorie:"Nel
mezzo del lago l’Imperatore Tiberio edificò un palazzo, cui
servivano di fondamento due navi gettate nel fondo dell’acqua, non
altrimenti di quello che facessero nel secolo XV° il Conte Borso
di Ferrara sul Po, Ludovico di Mantova sul Mincio ed i Principi Elettori
sul Reno, come narra Pio II° (Silvio Enea Piccolomini) nei suoi Commentarii".
Finalmente, nel settembre 1827, si tenta per la terza volta l’impresa
del recupero delle navi. Il nobile cavaliere Annesio Fusconi, dopo aver
studiato i tentativi dei suoi precursori, pensa di servirsi della "campana
di Halley" alla quale aveva apportato alcuni perfezionamenti in varie
parti, munendola, fra le nuove apparecchiature, di una pompa per l’afflusso
dell’aria al suo interno. Ne costruisce una abbastanza grande nella
quale possano prendere poste otto marangoni, quei famosi nuotatori genovesi.
Oltre a questo fa apprestare una piattaforma galleggiante, piuttosto ampia,
idonea a sostenere la campana ed a calarla in acqua mediante quattro argani.
Il cavalier Fusconi doveva essere, oltre che un uomo che si interessava
alla storia antica, anche una persona avveduta ed attenta alle relazioni
sociali. Questo si può evincere facilmente dal fatto che, dopo
aver costruito un magnifico palco ed un ponte per salirvi sopra, "vi
invitò gli spettatori più illustri ed il corpo diplomatico
oltre che tutta la nobiltà romana e forestiera che, numerosa, vi
accorse". Poiché, però, le fonti ci informano
che dell’impresa fu testimone una moltitudine innumerevole di persone,
dobbiamo arguire che anche il popolo fosse presente in gran numero a guardare
dalla riva del lago. Forse fu solo il richiamo di curiosità per
l’avvenimento mondano; ma ci piace pensare che l’interesse per
la cultura si stesse, piano piano, diffondendo presso il popolo minuto,
che certamente non era stato così cortesemente invitato. E
così il giorno dieci settembre dell’anno 1827 si diede inizio
al tentativo di recupero della nave che era più vicina alla riva:
fu immersa la campana con dentro gli otto marangoni che però, una
volta sul fondo, non poterono asportare grandi quantitativi di materiale.
Allora furono legate alcune gomene agli argani e, nella speranza di poter
strappare al lago tutta o almeno parte della nave, si avvolsero delle
cime allo scafo di quella. A forza di braccia si misero in tiro gli argani,
ma ancora una volta le corde si ruppero e l’impresa fu rimandata
anche a causa di un gran temporale sopraggiunto. Evidentemente Giove Pluvio,
piuttosto preoccupato, era intervenuto da par suo. Tuttavia era stato
portato sulla zattera abbastanza materiale del quale il Cavalier Fusconi
compilò, nelle sue Memorie, un preciso elenco: "due tondi
di pavimento uno di porfido orientale e l’altro di serpentino, pezzi
di marmo di varie qualità, smalti, mosaici, frammenti di colonne
metalliche, laterizi, chiodi, tubi di terracotta ed infine travi e tavole
di legno". Tali travi e tavole furono, ma solo in parte, utilizzati
per ricavarne bastoni, canne da fumare (cioè bocchini da sigaro)
ed ancora tabacchiere, segretini, cassettine da viaggio, libretti, ricordini
ecc..... L’impressione che ci eravamo fatti analizzando il comportamento
del cavalier Fusconi, quando apprendemmo del famoso palco mobiliare nonché
diplomatico, ci sembra ora confermata dall’utilizzo che fece delle
travi e delle tavole dell’antica romanità per ingraziarsi
la romanità del suo tempo. Ma tant’è, quando una persona
è avveduta alle relazioni sociali... Al termine del suo resoconto
il Cavaliere lamenta di non aver trovato "un ricco amatore vago
di siffatte peregrinità il quale incoraggisca il volenteroso autore
della macchina a nuovi più felici esperimenti". Serviva
evidentemente uno sponsor... Ma fortunatamente, dice uno storico, la sua
voce non viene raccolta. In ogni caso, e qui dice il contemporaneo, il
Fusconi era, con tutta evidenza, sinceramente interessato anche al proseguimento
dell’impresa del recupero delle navi. Secondo il Borghi "gran
parte degli oggetti estratti dal Fusconi furono, per consiglio dell’Accademia
di S. Luca, acquistati dall’eminentissimo cardinale Camerlengo pei
Musei Vaticani; ed i rimanenti oggetti furono conservati, per conto del
Fusconi stesso, nei magazzini di uno dei palazzi del principe Torlonia
duca di Ceri. È però notevole il fatto che, per quanto si
sia cercato, di questi oggetti null’altro si è rinvenuto se
non un frammento di trave con chiodi, de’ quali il Fusconi scrisse
che erano ‘con testa dorata’ oltre a due lunghe travi di larice,
unite da chiodi di ferro, ed alcuni tondini di porfido e di serpentino".
Il Montoni, da parte sua, raccontava che il principe don Alessandro
Torlonia mostrava con orgoglio nel suo palazzo, che occupava l’area
dell’attuale edificio delle Assicurazioni in Piazza Venezia, un gabinetto
di stile gotico, il cui pavimento era formato di tavoloni in terracotta
provenienti dalle navi nemorensi, e parecchi arredi costruiti col legname
recuperato nel 1827, come pure risulta dalla memoria citata. Di tutto
questo è fatta precisa menzione da Guido Ucelli che, con molta
esattezza, ci racconta del recupero delle navi, dei materiali ritrovati
e della tecnica di costruzione dei natanti. Dobbiamo essere grati
a quello studioso che ci ha trasmesso tutta la storia di quest’avventura
che, altrimenti, sarebbe andata persa, come perse sono le due antichissime
imbarcazioni.
Il quarto tentativo di recupero
Era molto tempo, secoli ormai, che ci si affannava, con
mezzi empirici sebbene sempre più perfezionati, a cercare di estrarre
dal Lago di Nemi quei reperti che era possibile recuperare. L’eco
di quei tentativi finalmente arrivò sia alle finestre del Ministro
della Pubblica Istruzione che a quelle dei Principi Orsini, risvegliando
l’interesse non solo di un privato, se pur nobile, come era accaduto
fino allora, ma soprattutto dei Pubblici Poteri. Si vuol sottolineare
che, a quel tempo, chiunque avesse abbastanza denaro e volesse dedicarsi
alla raccolta di cimeli del passato poteva, indisturbato, iniziare scavi
e ricerche nel proprio fondo divenendo proprietario di tutto ciò
che riusciva a trovare e disponendone poi a proprio piacimento. Il che
portò alla polverizzazione di buona parte di importantissimi reperti
della nostra storia antica che andarono ad arricchire, all’estero,
numerosi musei e raccolte private. Tuttavia è doveroso precisare
che quei personaggi, portandosi a casa loro quei tesori, non commettevano
alcuna illegalità nei nostri confronti. Si avvalevano soltanto
della carenza delle leggi italiane che nulla stabilivano sull’argomento.
È utile, a questo punto, accennare al diritto di proprietà
nei secoli passati. In epoca storica la proprietà era individuale
e si confondeva con la sovranità, nel senso che il "pater
familias" era l’unico soggetto che potesse essere titolare di
quel diritto. Dalla definizione romana dell’istituto si evince che
nell’antica Roma il cittadino libero avesse la possibilità
di usare e di disporre della cosa senza limitazione alcuna. "Usque
ad sidera, usque ad inferos" diceva l’orgoglioso quirite,
ed affermava con questo che il suo diritto di proprietà si estendeva
fino al cielo e fino agli inferi. I secoli passano e questi concetti cambiano
lentamente in conseguenza dei contatti con altri popoli, con altre civiltà,
con altri modi di concepire il diritto di proprietà. Uno sgretolamento
del concetto di proprietà si verifica nel Medioevo, ove è
soffocato da oneri ed obblighi. Ciò sia per l’influenza del
mondo germanico (in cui il nomadismo e l’economia pastorale avevano
portato ad una forma di godimento collettivo dei beni), sia per il fatto
che il concentramento della proprietà terriera in pochissime mani
costrinse i feudatari a cedere parte delle facoltà inerenti al
diritto di proprietà ad altri individui meno potenti ma più
numerosi. Il fondamento del diritto muta egli stesso: esso non è
più in funzione dell’individuo, ma della collettività.
La Costituzione Albertina, dopo avere affermato che tutte le proprietà
sono inviolabili, precisa che, quando l’interesse pubblico legalmente
accertato lo esiga, si può essere obbligati a cederle in tutto
o in parte. Il nostro codice all’art.832 dice che il proprietario
può godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro
i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.
Questo volo rapidissimo ci è stato utile per capire come,
nei secoli, il diritto di proprietà si sia lentamente evoluto da
rapporto esclusivo e rigido tra la cosa ed il suo proprietario, a rapporto
che debba tenere conto anche degli altri consociati ed, infine, anche
dello Stato. Ogni frutto ha il suo tempo di maturazione e, piano piano,
ci siamo maturati anche noi, sebbene con un certo ritardo nei confronti
di altri popoli più solleciti a considerare i propri reperti antichi
non alla stregua di souvenirs, ma come le grandi pietre con le
quali era stata costruita la loro storia. Questa acquisita maturità
del cittadino, trainata dai ceti più colti e perciò più
sensibili, fece il miracolo di far convergere l’interesse di un principe
aperto alle romane cose con l’attenzione del Ministero della Pubblica
Istruzione. La casa Orsini varò una campagna di ricerche diretta
dall’antiquario Eliseo Borghi con il consenso di quel Ministero.
Il miracolo era avvenuto ed il dado era tratto: il pubblico ed
il privato erano, finalmente, uniti per riscoprire la storia di Roma.
Per fortuna la tecnica aveva progredito e ci si potè avvalere della
collaborazione di un provetto palombaro, che esaminò accuratamente
la nave più vicina alla riva e tornò alla superficie con
una ghiera in bronzo raffigurante la testa di un leone che stringeva,
tra le fauci, un anello. Si trattava, come fu poi identificata, della
ghiera di un timone. Era il 3 ottobre 1895 e, con legittimo orgoglio,
il Borghi disse che quella data la si sarebbe dovuta ricordare nella storia
delle ricerche archeologiche. Si divelsero dallo scafo le famose "protomi
ferine" dalla forma di teste di felino, che stringevano tra i denti
anch’esse un anello. E poi, ancora, rulli sferici (dei quali si dirà
quando parleremo della avanzatissima tecnica, che avevano i romani, in
tema di costruzioni navali), rulli cilindrici (che fanno parte anch’essi
della stessa tecnica), paglioli, cerniere, filastrini in bronzo, tubi
di piombo, ancora tegole di rame dorato, laterizi di varie forme e dimensioni,
frammenti di mosaici con abbellimenti in pasta di vetro, lamine di rame
ed altro. Il 18 novembre viene poi individuata la seconda nave,
dalla quale si recupera altro materiale, fra cui un oggetto molto strano:
la decorazione del sostegno di uno dei quattro timoni raffigurante un
avambraccio ed una mano. Se ne conoscevano poche altre di queste strane
cose. Erano simboli "apotropaici": servivano ad allontanare
le influenze magiche e maligne. Se ne trovarono a volte nei sepolcri,
ed il loro nome deriva da una parola greca che significa "allontanante".
Gli antichi credevano che dalla punta delle dita emanasse un fluido che
avesse il potere di difendere. Una manus panthea fu rinvenuta presso
Mantova. Questa mano aveva i fori per essere fissata su un’asta,
e come una bandiera precedeva un manipolo di militi quale mezzo di difesa
e simbolo allo stesso tempo. Siamo sicuri, noi moderni che siamo
andati sulla luna, che i sensi siano solo cinque? E se i popoli antichi
avessero saputo, avessero intuito che ve ne è qualcun altro? Che
dire dei guaritori che con la sola apposizione delle mani tolgono alcuni
malanni di fronte ai quali la medicina dotta ed ufficiale s’era arresa?
E gli ipnotizzatori che spingendo le mani e le dita verso gli astanti
li costringono a vedere cose che non ci sono; oppure li costringono ad
un comportamento al di fuori della loro volontà? Forse qualcosa
emana dalla punta delle dita... Il concetto credo che sia stato espresso
anche nella Cappella Sistina: il dito di Dio che trasmette l’energia
vitale all’uomo. L’uomo che con una candela in mano, sulla porta
dell’infinito, si sforza di guardare lontano, ma riesce solo ad illuminare,
a stento, la punta dei suoi piedi. Gli antichi sapevano qualcosa più
di noi? È uno dei tantissimi interrogativi che riguardano il passato.
Ma andiamo avanti. Un altro oggetto attrasse attenzione e curiosità:
la testa di una Medusa. Racconta Carlo Montani presente al ritrovamento,
"usciva dalle acque azzurre del lago, tra le braccia del palombaro
che l’aveva divelta dallo scafo affondato. La bella testa di bronzo,
grondande acqua, pareva spargere lacrime di dolore per la sua pace di
secoli inopinatamente turbata". Per quanto riguarda le strutture
navali, lo stesso Borghi scrive: "insieme con tutti gli oggetti
preziosi di sopra menzionati, fu estratta dal lago una quantità
grandiosa di legname, in gran parte costituita di bellissime travi, in
ottimo stato di conservazione. Era quello un materiale che, quanto a valore
storico, presentava un interesse forse maggiore dei singoli oggetti d’arte
riportati alla luce. Erano più di 400 metri di travi, che sarebbero
servite come parti principali nella eventuale ricostruzione di quei monumenti
e che, almeno, avrebbero rappresentato le linee fondamentali per la ricostruzione
ideale di essi. Ma quelle travi —prosegue il Borghi—
quei preziosi avanzi che il fato aveva voluto nei secoli conservare e
poi rendere alla luce, furono lasciati a marcire sotto la pioggia ed a
polverizzarsi sotto i dardi cocenti del sole, onde non resta neppure il
diritto di attribuire ai barbari atti degli abitanti del luogo se, dopo
i guasti delle intemperie, misero mani anch’essi sugli avanzi di
quelle grandi memorie per farne legna da fuoco." Per fortuna
la maggior parte del prezioso materiale recuperato dal Borghi fu acquistato
dal governo per il Museo Nazionale Romano. Tuttavia il Montani afferma
che non poco materiale, giudicato meno importante, andò perduto
nelle mani di collezionisti privati, mentre qualche cimelio di grande
importanza, come la testa di Elios, che pare trovasse posto a prua della
nave, dopo qualche tempo che il Borghi la custodiva nel retrobottega del
suo negozio di antiquario, andò persa e non si seppe mai che fine
avesse fatto. Dicono gli abitanti del luogo che una statua femminile,
forse di Diana o di Drusilla, ed altre otto statuette, dopo essere stata
nascosta in un fascio di rami, fu trasportata per un ripido sentiero e
non se ne seppe più nulla. È probabile che sia quella che
fa bella mostra di sé al British Museum. Una statuetta, questa
volta di Eros, alberga nel Museo dell’Ermitage dove, dice il Waldhauer,
pervenne dopo essere stata dapprima portata in Inghilterra. Si ricordano
pure un simpulum —un mestolo— di bronzo conservato al
Louvre ed un grande elmo monumentale conservato a Berlino. Tutto questo
saccheggio, che è durato secoli, ha finalmente termine con i recuperi
dell’antiquario Borghi. Arriverà lo Stato a difendere ed a
conservare i pezzi della nostra storia, sottraendone ai privati la disponibilità
ed avocando a sé il diritto di ricerca e di conservazione. L’unica
consolazione nei riguardi degli oggetti esposti nei musei esteri è
che sono circondati da quel rispetto e dal quel riguardo che, forse, non
hanno trovato da noi; e che la nostra storia e la nostra civiltà
parlano attraverso loro. Ambasciatori di un grande passato.
L’intervento dello
Stato
Era il 1895. Lo Stato Italiano intervenne per raggiungere un obiettivo
che oggi sembra ovvio ma che allora era una novità: la salvaguardia,
il recupero e la conservazione dei reperti antichi. Al fine, quindi, di
impedire ai privati l’ulteriore dispersione di quelle cose antiche,
il Ministro della Pubblica Istruzione, Guido Baccelli, sollecita all’Ammiraglio
Morin, Ministro della Marina, la sua collaborazione. Più precisamente
gli chiede l’intervento di un ingegnere navale e di un bravo palombaro
per effettuare un’accurata ispezione e stabilire il modo migliore
per recuperare quelle costruzioni sommerse nel lago. Interviene
così il Genio Navale, che incarica sia il Tenente Colonnello Ing.Vittorio
Malfatti che un espertissimo palombaro, il nome del quale non è
pervenuto fino a noi. Quest’ultimo, dopo molte immersioni e diligenti
accertamenti, permette all’Ing.Malfatti una serie di identificazioni,
di rilievi e di studi che questi riunisce in un interessante libro a carattere
tecnico. In questo volume l’ingegnere propone anche cosa si dovesse
fare per recuperare le navi. Egli relaziona che la prima nave dista dalla
riva circa cinquanta metri e precisa che è quella esplorata dall’Alberti,
dal De Marchi e, probabilmente, dal Fusconi. È da questa che il
Borghi trasse il suo ricco bottino ed è adagiata sul fianco sinistro
ad una profondità da cinque a dodici metri. Questa strana profondità
è spiegabile per la forte ripidità con cui il fondo del
lago vulcanico, conico, scende verso il centro, e la nave vi riposa avendo
una estremità verso la riva e l’altra verso il centro. Emergono
dal fango solo le estremità degli scalmi, e sono evidenti i danni
causati dai ripetuti tentativi di recupero che ne hanno strappato qui
e là intere parti. Lontano duecento metri, ad una profondità
da quindici a venti metri circa, giace la seconda nave, anch’essa
adagiata sul lato sinistro ed anch’essa semi coperta dal fango. È
interessante la tecnica usata per il rilevamento delle dimensioni di entrambe:
si riportarono alla superficie dell’acqua i contorni delle strutture
per mezzo di piccoli gavitelli assicurati dal palombaro ai profili delle
navi. L’Ing. Malfatti analizza anche il legname, i bronzi e le paste
vitree al fine di stabilirne lo stato di conservazione. Si vuole sottolineare,
a questo punto, la meticolosità e la competenza con le quali furono
fatte queste ricerche per dimostrare, se ve ne fosse ancor bisogno, quale
sia la differenza con quelle che fino ad allora le avevano precedute.
Tuttavia i tempi non erano ancora maturi: il grande pubblico non era coinvolto
dal punto di vista culturale e, salvo pochi spiriti eletti interessati
al lato scientifico, quei pochi che la seguivano erano sollecitati solo
dalle storie più o meno fantastiche di ricchi tesori. Inoltre c’è
anche da considerare che l’Italia era unita da pochi anni, i problemi
erano enormi, le soluzioni lontane e la vita dura; ed il popolo minuto,
vuoi perché assorbito dalla cura di sopravvivere, vuoi per scarsa
cultura, era comprensibilmente piuttosto lontano dall’interessarsi
fattivamente delle Navi di Nemi. Nonostante questo vi furono campagne
di stampa e scritti sull’argomento che tentavano di trascinare l’adesione
della gente a prendere parte al problema del recupero di quelle navi,
ma…..non lo si sentiva ancora come un problema comune. Si parlò
addirittura di "regge natanti imperiali ricolme di ogni preziosità"
e, mentre si favoleggiava di scenografiche visioni, il pubblico, il
grande pubblico, si allontanava sempre più dalla vera essenza della
questione. Vi furono alcune proposte di recupero da parte di vari personaggi;
alcune erano studi seri e fattibili, molte altre solo fantasticherie dalla
realizzazione impossibile. Passarono così molti anni che videro
il fiorire di scritti ed opuscoli che descrivevano quelle imbarcazioni
con molta fantasia riaccendendo le leggende del lago di particolari fantastici
e romantici. Vi furono delle ricostruzioni così dette "ideali"
di quei natanti e si aggiunsero e crearono particolari che erano di pura
fantasia. Finalmente nell’anno 1926 si torna a trattare del recupero
di quelle navi con serietà ed impegno. Si crea una Commissione
di Studio affidandone la presidenza al Senatore Corrado Ricci, che vi
infonde il suo entusiasmo sereno e fattivo, tutto teso al conseguimento
del risultato finale. Si esaminano studi e progetti scegliendoli e valutandoli
con criteri selettivi, escludendo i tanti che propongono soluzioni impossibili
da realizzare, quando addirittura di fantasia. Infine la Commissione ritiene
idoneo il metodo di lavoro proposto dal Malfatti: l’abbassamento
del livello del lago fino a far emergere le due navi. Il 9 aprile 1927,
in un discorso alla Reale Società Romana di Storia Patria, il Capo
del Governo, Benito Mussolini, annuncia la decisione di recuperare le
due grandi navi sommerse. Ricorda la grandezza di Roma, della sua storia,
della sua civiltà. Afferma come questo sia un debito d’onore
verso la cultura classica e verso la dignità del nostro Paese.
Riassume i lavori della Commissione di periti nel campo delle antichità
classiche e dell’ingegneria idraulica che, sotto la guida del Senatore
Ricci, ha lavorato per alcuni mesi studiando ed esaminando i numerosi
progetti che le venivano sottoposti. Parla di come sia previsto lo svuotamento
parziale del lago e di come si effettueranno indagini archeologiche sulle
navi allorché saranno all’asciutto. Tali ricerche saranno
estese anche alle loro immediate vicinanze al fine di recuperare eventuali
reperti caduti fuori bordo. Infine si svuoteranno e si solleveranno gli
scafi che saranno trasportati e sistemati in un museo appositamente costruito
nella parte pianeggiante della sponda. Questo discorso è l’inizio
ufficiale del coinvolgimento dello Stato che si assume l’iniziativa
e l’esclusiva del recupero di quelle due antiche navi romane. Antiche
e sfortunate navi romane.
La dea, il tempio, il sacerdote e l’emissario
Era dunque deciso che si dovesse svuotare parzialmente il
lago di Nemi per far riemergere le due antiche navi romane. Ma non scavando,
come si era proposto, un cunicolo che riversasse le acque del lago di
Nemi nel lago Albano, che era ad un livello più basso, ma utilizzando
l’antico emissario affinché le portasse al mare. A questo
punto, però, è necessario sospendere il racconto del recupero
delle navi romane per parlare dell’antico emissario che avrà
l’importantissima funzione di abbassare il livello di quello specchio
d’acqua. Torneremo indietro nel tempo. Torneremo all’antica
Roma e anche ad un tempo anteriore della fondazione dell’Urbe. Sembra
quasi che questa gloriosa città ci voglia richiamare a parlare
di lei, come se si fosse avveduta che, nello slancio di trattare di cose,
di storie e di imprese moderne, ne avessimo perso il ricordo e, spintici
troppo avanti nei secoli, fossimo dimentichi che ad essa tutto si debba
riferire. Ebbene, sulla riva settentrionale del lago di Nemi esisteva,
ed esiste ancora, il santuario di Diana, che vanta origini antichissime:
sicuramente anteriori al V secolo a.C. e che fu frequentato fino al IV
secolo d. C.. Era sede del culto di quella dea e del rito cruento
della successione del "rex nemorensis", suo sacerdote. Parleremo
dell’antica divinità, del suo tempio, del suo sacerdote nonché
della relazione esistente fra tutto questo ed il famoso emissario del
quale abbiamo trattato più indietro. Era Diana uno dei principali
numi della Lega Latina, cui le città confederate prestavano un
culto comune. Il suo centro culturale, sin da epoche immemorabili, sorgeva,
appunto, sulla sponda settentrionale del lago di Nemi, nel mezzo di un
bosco sacro. Poi, quando Roma prevalse sulle città di quella Lega,
volle annettersi tale culto seguendo la sua politica di acquisire le credenze
religiose dei popoli vinti, ed eresse alla dea, durante il regno di Servio
Tullio, un tempio sul Colle Aventino. Diana era la divinità della
vita, della caccia e dei boschi, ed era anche invocata dalle donne come
protettrice dei parti, quando, in occasione di una festa alle idi di Agosto,
con solenni rituali si recavano in pellegrinaggio notturno al Santuario
di Nemi. Alle pareti del tempio ed anche sulle colonne e sugli alberi
del bosco sacro erano appesi doni, tavolette votive, "ex voto"
per grazia ricevuta e festoni dedicati alla dea. Gli schiavi erano a lei
devoti. Era messa in relazione con la luna e le sue fasi, tanto che fu
detta "triforme". Proteggeva le strade e i crocicchi e per questo
era detta, anche, "trivia". Presiedeva sia alle pratiche magiche
che agli inferi ed era identificata con la dea greca Artemide. Quanto
ai suoi templi, il multiforme, antichissimo e venerato nume, ne aveva
numerosi in tutto il mondo, ma il più antico e venerato era proprio
quello di Nemi. Il santuario era situato nel bosco (il "nemus",
da cui prese il nome l’odierna Nemi) e fu più volte rimaneggiato
ed ampliato nel corso dei secoli. È costruito nella parte pianeggiante
a Nord del lago, proprio sotto all’odierno paese. Di quel tempio
parlano molti autori antichi come Catone, Virgilio, Orazio, Ovidio, Plinio,
per citare solo i più grandi, e ciò sta a dimostrare quanto
fosse importante, conosciuto e frequentato. Sono rimasti recinti e
colonnati, nicchie e terrazze, muraglioni, scalinate ed ambienti chiusi
nei quali si trovarono interessantissimi reperti ed "ex voto"
in terracotta. Vasi di marmo ed ancora numerose statue di varie dimensioni,
tra cui una testa colossale della dea. Diciamo, ora, del "rex
nemorensis", cioè del sacerdote di quel tempio. Era, per tradizione,
uno schiavo fuggitivo che succedeva al suo predecessore dopo averlo ucciso
in duello; non prima però di aver strappato un ramo di vischio
da un albero di quercia ed averglielo consegnato. Questa cruenta successione
ha una giustificazione nel fatto che il sacerdote nemorense, essendo la
personificazione della natura boschiva e della fertilità, che era
uno degli aspetti di Diana, doveva essere sempre nel pieno delle forze,
non si doveva ammalare e non doveva nemmeno morire di vecchiaia. Solo
uno schiavo in fuga poteva quindi accettare e desiderare un simile sacerdozio.
Solo un uomo già fuori della società, che non era titolare
di alcun diritto, e anzi in reale pericolo di vita, poteva cercare di
risolvere la sua esistenza ed ottenere asilo divenendo sacerdote di una
dea in un tempio che comportava implicitamente una morte certamente cruenta.
Egli portava al suo predecessore un rametto di vischio. Un ramo che
non nasceva direttamente dalla terra, ma si doveva strappare da una pianta
che si protendeva verso il cielo. Una cosa, quindi, che stava tra cielo
e terra; e che era diversa da tutte le altre, non appartenendo né
alla sfera terrena né a quella divina. Il "rex nemorensis"
presiedeva al continuo cambiamento della natura che si trasforma e rinnova
continuamente col mutare delle stagioni. Durante quel periodo lo schiavo
fuggito poteva vivere e pregare nel tempio con il cuore quasi tranquillo.
Ma questo fintanto che un altro uomo, disperato ed in fuga com’egli
era stato, si presentasse a lui con un ramo di vischio… e la morte
di uno dei due doveva essere un vero e proprio sacrificio, poiché
il sangue del vinto doveva fecondare la terra. Questo rituale così
feroce e stranissimo aveva origini che si perdono nell’antichità
più remota. Questo sacerdozio insanguinato rimase fino all’età
imperiale inoltrata, e Svetonio narra che Caligola, ritenendo addirittura
che il sacerdote nemorense dell’epoca fosse in carica da troppo tempo,
lo fece uccidere da un successore più forte. Nel II secolo d.C.
il duello per la conquista di quell’altare divenne simbolico, mentre
il culto di Diana, che si andava affievolendo sempre più, durò
poco oltre l’inizio del cristianesimo. Il suo tempio fu pian piano
dimenticato. Non più preghiere, non più processioni né
canti di donne, e la terra, l’incuria e l’oblio lo ricoprirono
completamente nel corso dei secoli. Finalmente siamo arrivati a parlare
dell’emissario che, ricordiamo, era stato scelto per far defluire
le acque del lago di Nemi e riportare le navi romane alla luce. Quest’opera
ha veramente dello straordinario sia per le difficoltà che doveva
superare l’antichissimo scavatore, sia per i mezzi tecnici allora
a disposizione, sia per l’audacia della decisione che si riprometteva
di far defluire quelle acque attraverso la campagna, fino al mare distante
trenta chilometri. E tutto questo, ecco la cosa straordinaria, prima della
fondazione di Roma; forse addirittura al tempo della civiltà etrusca!
Il perché di questa opera ciclopica era la necessità
di non far giungere l’acqua fino al tempio che sorgeva, ricordiamo,
nella parte pianeggiante della riva volta a settentrione. Nella più
remota antichità il livello del lago era superiore all’attuale,
e piogge e fonti a volte facevano sì che il terreno pianeggiante
quasi fosse sommerso, e il tempio spesso restava prigioniero ed inaccessibile
in quella che diventava una perenne palude. Così, con i poveri
mezzi di allora, si costruì una galleria della lunghezza di 1.653
metri attraverso la durissima roccia che incorniciava quel lago vulcanico.
La prima parte della galleria è interrotta da vari diaframmi di
pietra che funzionavano da filtro al fine di trattenere fuori del cunicolo
eventuali materiali che potessero ostruirlo. Inoltre vi sono vari pozzi
verticali adibiti all’areazione, similmente ad altre opere dell’antica
Roma, che sbalordiscono noi moderni per la loro notevolissima funzionalità
e perfezione tecnica. Tale era il manufatto che si volle rimettere
in ripristino per realizzare lo svuotamento parziale del lago di Nemi.
La sintetica descrizione di quell’opera antica si è resa
necessaria per ben comprendere ma soprattutto apprezzare nella pienezza
della sua grandiosità, sia l’opera stessa che l’utilizzo
moderno che, dopo qualche millennio, se ne volle fare. Detto ciò,
nel prossimo capitolo, narreremo come si riuscì nell’impresa,
usando l’antichissima opera e la tecnica moderna.
Si riportarono alla luce le due antiche navi romane abbassando il livello
del Lago di Nemi
L’entusiasmo era vivissimo e l’opera veramente grande: riportare
alla luce due antiche navi romane abbassando il livello del Lago di Nemi
facendone defluire le acque attraverso una galleria lunga 1.653 metri
scavata nella lava alcuni millenni prima! La notizia aveva già
fatto il giro del mondo. Era stata riportata dai giornali di tutti i Paesi e gli
ingegneri delle maggiori potenze navali (prima fra tutte l’Inghilterra,
che possedeva una grande flotta sia commerciale che da guerra) erano molto
interessati a conoscere quali fossero le soluzioni tecnico-marittime degli
antichi romani, che avevano navigato per tutto il Mediterraneo. Fu
necessario esaminare a fondo l’emissario che era in condizioni molto
più precarie di quanto si pensasse. L’entrata era difficile
e si dovevano eseguire diversi lavori per renderla più accessibile.
Andando avanti nella galleria ci si avvide che era ostruita da frane e
da depositi rocciosi che non avrebbero permesso il deflusso dell’acqua
nella misura che era stata prevista nei calcoli degli ingegneri. Era quindi
necessario ispezionarla tutta al fine di rendersi conto esattamente dello
stato generale dell’intera antichissima opera. Due uomini coraggiosi
si offersero di percorrerla nell’intera lunghezza: erano Augusto
Anzil e Mafaldo Corese, che camminando con l’acqua che in certi punti
gli arrivava al collo, spostandosi a tratti sulle mani e sulle ginocchia,
affondando nella melma e tra sassi grandi e piccoli che impedivano loro
il movimento, e insomma rischiando mille volte la vita, riuscirono ad
uscire dalla parte del lago. Dal racconto dei due uomini si dedusse che
sarebbero stati necessari molti lavori per potersi servire di nuovo di
quella galleria, la cui costruzione era cominciata contemporaneamente
sia da una parte che dall’altra. Questo si potè desumere osservando
i segni lasciati sulla roccia dagli attrezzi di scavo che, essendo contrapposti,
stanno a dimostrare che due squadre lavorarono una ad incontrare l’altra.
Ma lasciamo che l’ingegnere Augusto Biancini (presidente del
Comitato Industriale Scoprimento Navi Nemorensi, costituito da varie società,
che eseguirà i lavori di prosciugamento) parli così nella
sua dotta relazione a proposito dell’emissario del lago di Nemi:
"Le incisioni, tutt’ora visibili, lasciate sulla roccia dagli
arnesi a punta adoperati, attestano il lavoro duro, paziente ed estremamente
penoso che gli schiavi hanno dovuto compiere, obbligati a lavorare raggomitolati
od in posizione orizzontale e con limitatissima possibilità di
movimenti. L’incontro è documentato dalla opposta direzione
delle incisioni, ancora nettamente visibili, lasciate sulla roccia dagli
utensili di lavoro ed è stato raggiunto per via di tentativi guidati,
verosimilmente, da segnali acustici. In tal modo si sono raccordati i
due avanzamenti, che si trovano a divergere fra loro di circa quattro
metri in senso planimetrico e di circa due in senso altimetrico. Errore
certo non grave, quando si pensi ai mezzi primitivi che, allora, si possedevano
per tracciare e mantenere le direzioni di avanzamento e soprattutto quando
si pensi che accade, talvolta, anche oggi di riscontrare nelle nostre
gallerie errori non molto minori, malgrado la perfezione degli strumenti
e dei metodi moderni". Fu addirittura trovata in una nicchia
una piccola lucerna ad olio in terracotta che aveva illuminato la fatica
di quegli uomini. Quanta fu l’emozione nel ritrovare quel povero
oggetto che era stato testimone di tale avventura e di tanto sudore. Se
le cose potessero parlare! E quanto sa essere grande questo piccolo uomo
che, con mezzi poverissimi, non teme di intraprendere opere grandiose
che resteranno a parlare di lui ben dopo la fine della sua esistenza.
Ma i millenni non erano passati invano, e si dovette rimediare ai
guasti del tempo ristrutturando e sistemando la galleria. Il Ministro
dei Lavori Pubblici adoperò tutta la potenza dei mezzi allora disponibili:
dagli argani elettrici alle perforatrici pneumatiche, agli esplosivi;
tutto questo pur tenendo conto non solo del fine ultimo cui doveva servire
l’emissario, cioè il parziale svuotamento del lago, ma anche
della necessità di non stravolgere, con i lavori eccessivi, l’integrità
del monumento. Il Capo del Governo era regolarmente informato dell’andamento
dei lavori con rapporti che gli pervenivano ogni quindici giorni. Nel
mese di settembre 1928 i lavori di sistemazione furono portati a termine,
ed il primo ottobre se ne effettuò il collaudo dopo un’ulteriore
ispezione di alti funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici. Raccontano
coloro che ebbero la fortuna di essere presenti che, appoggiando l’orecchio
alla roccia "si sente lontano il rombo dell’acqua scrosciante
nel lungo speco ed all’improvviso il flutto ne esce e precipita spumeggiando".
Era lo spettacolo che si poteva ammirare allo sbocco della galleria in
Valle Ariccia. Nel Lago di Nemi, intento, grandi pompe idrovore
giro del mondo. Era stata riportata dai giornali di tutti i Paesi e gli
ingegneri delle maggiori potenze navali (prima fra tutte l’Inghilterra,
che possedeva una grande flotta sia commerciale che da guerra) erano molto
interessati a conoscere quali fossero le soluzioni tecnico-marittime degli
antichi romani, che avevano navigato per tutto il Mediterraneo. Fu
necessario esaminare a fondo l’emissario che era in condizioni molto
più precarie di quanto si pensasse. L’entrata era difficile
e si dovevano eseguire diversi lavori per renderla più accessibile.
Andando avanti nella galleria ci si avvide che era ostruita da frane e
da depositi rocciosi che non avrebbero permesso il deflusso dell’acqua
nella misura che era stata prevista nei calcoli degli ingegneri. Era quindi
necessario ispezionarla tutta al fine di rendersi conto esattamente dello
stato generale dell’intera antichissima opera. Due uomini coraggiosi
si offersero di percorrerla nell’intera lunghezza: erano Augusto
Anzil e Mafaldo Corese, che camminando con l’acqua che in certi punti
gli arrivava al collo, spostandosi a tratti sulle mani e sulle ginocchia,
affondando nella melma e tra sassi grandi e piccoli che impedivano loro
il movimento, e insomma rischiando mille volte la vita, riuscirono ad
uscire dalla parte del lago. Dal racconto dei due uomini si dedusse che
sarebbero stati necessari molti lavori per potersi servire di nuovo di
quella galleria, la cui costruzione era cominciata contemporaneamente
sia da una parte che dall’altra. Questo si potè desumere osservando
i segni lasciati sulla roccia dagli attrezzi di scavo che, essendo contrapposti,
stanno a dimostrare che due squadre lavorarono una ad incontrare l’altra.
Ma lasciamo che l’ingegnere Augusto Biancini (presidente del
Comitato Industriale Scoprimento Navi Nemorensi, costituito da varie società,
che eseguirà i lavori di prosciugamento) parli così nella
sua dotta relazione a proposito dell’emissario del lago di Nemi:
"Le incisioni, tutt’ora visibili, lasciate sulla roccia dagli
arnesi a punta adoperati, attestano il lavoro duro, paziente ed estremamente
penoso che gli schiavi hanno dovuto compiere, obbligati a lavorare raggomitolati
od in posizione orizzontale e con limitatissima possibilità di
movimenti. L’incontro è documentato dalla opposta direzione
delle incisioni, ancora nettamente visibili, lasciate sulla roccia dagli
utensili di lavoro ed è stato raggiunto per via di tentativi guidati,
verosimilmente, da segnali acustici. In tal modo si sono raccordati i
due avanzamenti, che si trovano a divergere fra loro di circa quattro
metri in senso planimetrico e di circa due in senso altimetrico. Errore
certo non grave, quando si pensi ai mezzi primitivi che, allora, si possedevano
per tracciare e mantenere le direzioni di avanzamento e soprattutto quando
si pensi che accade, talvolta, anche oggi di riscontrare nelle nostre
gallerie errori non molto minori, malgrado la perfezione degli strumenti
e dei metodi moderni". Fu addirittura trovata in una nicchia
una piccola lucerna ad olio in terracotta che aveva illuminato la fatica
di quegli uomini. Quanta fu l’emozione nel ritrovare quel povero
oggetto che era stato testimone di tale avventura e di tanto sudore. Se
le cose potessero parlare! E quanto sa essere grande questo piccolo uomo
che, con mezzi poverissimi, non teme di intraprendere opere grandiose
che resteranno a parlare di lui ben dopo la fine della sua esistenza.
Ma i millenni non erano passati invano, e si dovette rimediare ai
guasti del tempo ristrutturando e sistemando la galleria. Il Ministro
dei Lavori Pubblici adoperò tutta la potenza dei mezzi allora disponibili:
dagli argani elettrici alle perforatrici pneumatiche, agli esplosivi;
tutto questo pur tenendo conto non solo del fine ultimo cui doveva servire
l’emissario, cioè il parziale svuotamento del lago, ma anche
della necessità di non stravolgere, con i lavori eccessivi, l’integrità
del monumento. Il Capo del Governo era regolarmente informato dell’andamento
dei lavori con rapporti che gli pervenivano ogni quindici giorni. Nel
mese di settembre 1928 i lavori di sistemazione furono portati a termine,
ed il primo ottobre se ne effettuò il collaudo dopo un’ulteriore
ispezione di alti funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici. Raccontano
coloro che ebbero la fortuna di essere presenti che, appoggiando l’orecchio
alla roccia "si sente lontano il rombo dell’acqua scrosciante
nel lungo speco ed all’improvviso il flutto ne esce e precipita spumeggiando".
Era lo spettacolo che si poteva ammirare allo sbocco della galleria in
Valle Ariccia. Nel Lago di Nemi, intento, grandi pompe idrovore  aspiravano
le acque e le immettevano nella galleria dell’emissario ormai liberato
dalle rocce e sedimenti che lo avevano parzialmente ostruito. Molti di
quei testimoni scrissero la loro emozione al vedere le acque uscire dalla
terra e correre verso il mare. Infine si era giunti, dopo speranze, dubbi
ed un durissimo lavoro, alla certezza che l’opera avrebbe, finalmente,
potuto realizzarsi; che la si stava già realizzando. Il 16
ottobre si verificò una leggera scossa tellurica, quasi che la
natura si risvegliasse avvertendo gli uomini che, nonostante i lavori
nel suo seno, le dovessero rispetto e qualcuno temé... un sinistro
preavviso. Si dette incarico all’Osservatorio Geofisico di Rocca
Di Papa, così vicino al Lago di Nemi, di tenere sotto controllo
il territorio al fine di comunicare eventuali, ulteriori scosse. Fortunatamente,
però, il sisma era locale e non se ne verificarono altri. Si poté,
così, iniziare lo svaso del lago ed il 20 ottobre 1928 Mussolini,
accompagnato dal Sottosegretario agli Interni e dai Ministri della Pubblica
Istruzione e dei Lavori Pubblici, mise in funzione l’impianto idrovoro.
La grande impresa, finalmente, iniziava. Quattro grossi tubi aspiravano
l’acqua del lago e la gettavano nell’emissario. Dell’avvenimento
si parlò in tutto il mondo e tutto il mondo volse lo sguardo verso
Roma. È impossibile far cenno dell’ammirazione\invidia che
generò l’impresa. Nessun altro aveva due grandi ed antiche
navi romane da riportare alla luce, e pochi avrebbero avuto le capacità
di farlo in maniera degna. Le grandi pompe idrovore lavoravano quasi in
silenzio facendo abbassare il livello del lago in modo continuo anche
se quasi impercettibile. Le acque venivano convogliate nell’antico
emissario e, attraverso l’Ariccia, giungevano fino al mare. Ma l’opera
non poteva limitarsi al solo abbassamento del livello del lago di Nemi.
Molti altri problemi dovevano essere affrontati e risolti. A tal fine
si riunì la Commissione Nemorense che era stata nominata
dal Ministro per l’Educazione Nazionale, Giuseppe Belluzzo, della
quale facevano parte il sen.Corrado Ricci, l’ing.Malfatti, l’ing.Biagini
ed altri. Tale commissione decise la costruzione di una strada che doveva
unire la città di Genzano al Lago. Inoltre pose le basi per la
soluzione di altri problemi ugualmente necessari ed urgenti: provvedere
alla costruzione di un riparo provvisorio per le due navi nonché
tutti gli oggetti antichi che si sarebbero trovati e, successivamente,
ad edificare un museo definitivo che potesse degnamente accogliere il
tutto. È il caso di sottolineare che il Museo delle navi in questione
sarà un’opera fatta "ad hoc", nel senso che è
uno dei pochi ad essere stato costruito per ospitare uno specifico reperto.
Altro problema che la commissione Nemorense doveva affrontare e risolvere
era la tutela della splendida corona vegetale che arricchiva le sponde
del Lago di Nemi. Per la sua conservazione venne, addirittura, licenziata
una legge a carattere paesaggistico che tutelava quell’ornamento
arboreo dichiarando di pubblica utilità quei magnifici boschi.
Il Genio Civile, che per ordine del Consiglio dei Ministri costruiva la
strada che va da Genzano al lago, si trovò ad affiancare parte
di un’antica strada romana che si dipartiva dalla Via Appia e prendeva
il nome di Via Virbia o Clivus Aricinus, lastricata con
la tipica pavimentazione a lastroni a basole. Il nome di Viribio sembra
derivi da vir e bios , dove vir originerebbe da virae,
ossia dal nome delle ninfe degli alberi, che unito a bios prenderebbe
il significato di vita vegetale, ovvero designerebbe una divinità
campestre. Ebbene, questa strada si dirigeva all’Artemisio, da dove
la Via dei Trionfi saliva al Tempio di Giove Laziale su quello che, oggi,
si chiama Monte Cavo. Ma torniamo alle navi. Il 28 marzo 1929 affiorarono
le più alte strutture della prima nave. I giornali e le radio di
tutto il mondo fanno da eco all’importante ritrovamento ed ancora
una volta il nome di Roma vola sulle ali del vento. La notizia viene immediatamente
data dal Capo del Governo col seguente rapporto: "Oggi hanno cominciato
ad affiorare i resti della parte poppiera della prima nave, di quella
parte, cioè, che, per essersi trovata a minore profondità
sotto il livello del lago, è stata più fortemente danneggiata
dai tentativi di recupero compiuti nei secoli scorsi. Trattasi, per ora,
di alcune travi e tavoloni rivestiti, questi ultimi, di lamierino di piombo,
tuttora ben consistenti e fra loro connessi, dai quali spiccano lunghi
chiodi che congiungevano le strutture rimaste con quelle strappate ed
asportate anticamente. Ad acque chiare e tranquille ed a luce propizia,
il che si verifica specialmente nelle ore del mattino, è dato di
scorgere altre strutture, emergenti qua e là dal limo che le ricopre,
il cui andamento lascia intravedere la maggiore ampiezza che assume la
mole man mano che scende in profondità". Finalmente
emerge la nave più vicina alla riva. Quella che giaceva ad una
profondità minore e che, essendo recuperata per prima, sarà
d’ora in poi chiamata prima nave. Oltre alle numerose
fotografie che furono fatte allo scafo, da tutte le angolazioni; oltre
alle foto scattate ai numerosi reperti che vi si trovavano sopra, siamo
in possesso anche di un’accuratissima relazione dell’esplorazione
della parte emersa della nave, stilata prima ancora di procedere alla
rimozione dei reperti stessi. Tale relazione la dobbiamo al prof. Cultrera,
Sovrintendente dell’epoca, che il 1° maggio del 1929 dette inizio
ad una rigorosa serie di rilievi, di osservazioni e di fotografie che
furono la base di partenza di tutti i successivi attenti studi di archeologia
marina. L’importanza di quell’opera sta nell’aver fissato
nel tempo il momento in cui la nave emergeva dalle acque per effetto dell’abbassamento
del livello del lago. Quel momento era irripetibile, ed era quindi necessario
documentarlo con la massima precisione. Come uno sciame di api attornia
l’alveare, così la nave romana del lago di Nemi richiama un’immensa
folla di visitatori attratti dall’eccezionalità dell’evento,
fra i quali i giornalisti stranieri invitati dallo stesso Ministro della
Pubblica Istruzione. Costoro, di fronte ad una nave di 2000 anni riportata
alla luce del sole, scriveranno innumerevoli ed importanti articoli sull’argomento,
esaltando la civiltà dell’antica Roma (e la bravura di quella
moderna). Pochi giorni dopo, l’ing.Vittorio Malfatti - l’ufficiale
del Genio Navale che, avvalendosi di un esperto palombaro, aveva compiuto
accuratissime esplorazioni, diligenti accertamenti, importanti rilievi
e studi sulle navi - ha la grande soddisfazione di guidare un folto gruppo
di tecnici d’alto livello a visitare lo scafo da poco emerso. Di
tale gruppo fanno parte i congressisti della Insitution of naval architects,
alcuni Ammiragli della Real Marina inglese, ed ingegneri dell’industria
navale britannica. Tutti costoro sfilano davanti alla nave ammirandola
in ogni particolare, attenti alle spiegazioni dell’ing. Malfatti;
ed affermano che questa impresa dona alla cultura mondiale un enorme contributo
di conoscenza, unendo così la loro voce autorevole a quella dei
giornalisti della stampa estera, che poco prima avevano narrato l’eccezionale
evento sui quotidiani di tutto il mondo. Quei signori, giustamente orgogliosi
di far parte della Marina più importante di allora, sia dal lato
qualitativo che quantitativo, ebbero molto a meravigliarsi che alcune
soluzioni tecniche ritenute di loro invenzione fossero già conosciute
ed usate dai romani 2000 anni prima. Di tali ritrovati tratteremo nell’ultima
parte, quando parleremo del museo. C’è un aspetto che,
crediamo, non debba sfuggire a chi desideri ripercorrere quegli anni se
vuol cogliere appieno il significato e le ragioni di tutta l’impresa.
In Italia in quel periodo c’era una forte rivalutazione della Roma
antica, e gli atti politici erano spinti dal desiderio di ripercorrerne
in qualche modo la storia, cercando di eguagliarne il cammino. Si volle
conquistare un impero, si vollero ingrandire i confini d’Italia,
si volle, tra le altre cose, riportare alla luce quelle due antiche navi.
Certamente la democrazia ha i suoi difetti, ma non crediamo che vi sia
una forma migliore di governo. Dato per scontato questo - e resti ben
chiaro - la dittatura a modesto avviso dello scrivente ha almeno la caratteristica
di dare esecuzione immediata alla volontà di chi è al potere.
In regime democratico si discute, si mette ai voti, si replica, si soppesa...
le decisioni sono valutate e ponderate, ma il tempo passa e a volte i
problemi hanno troppo lenta soluzione. Al contrario, un regime dittatoriale
non ammette possibilità di discussione. La volontà è
una, e basta. Quel che si vuole fare, viene subito fatto. Quando va male...
va male. Ma stavolta andò bene. Ecco spiegato perché il
recupero delle navi vi fu proprio in quel periodo. Non solo perché
era possibile disporre finalmente di potenti pompe idrovore; ma perché
quell’impresa faceva parte della politica generale del momento. Ed
ecco perché l’ing. Malfatti volle e poté condurre personalmente,
in veste di cicerone, quei tecnici d’alto livello e quegli Ammiragli
inglesi a visitare ed ammirare quella vittoria archeologica. Ed ecce perché
il Ministro della Pubblica Istruzione volle e poté invitare i rappresentanti
della stampa estera. Gli studiosi e gli archeologi che da tanti anni si
occupavano di quelle vestigia seppero cogliere il momento politico ed
offrirono la loro collaborazione entusiasta. Molte aziende dettero gratuitamente
il loro apporto tecnico, e tutte queste energie convergenti... salvarono
le navi. Peccato che agli uomini non sia dato di guardare, nemmeno
un poco, nel loro futuro. Se lo avessero potuto... forse avrebbero lasciato
le navi dov’erano. Questo però nulla toglie all’eccezionale
grandiosità dell’opera; è solo il triste commento di
chi scrive pensando al drammatico destino cui le navi andarono incontro.
Si istituì un libro dei visitatori sul quale si possono ancora
leggere gli autografi dei personaggi allora più in vista, cominciando
dalla famiglia reale e via via continuando con reali di altri Stati, ministri,
scienziati, studiosi, e molte altre persone più o meno importanti
che vollero vedere l’antico reperto. Per dovere di verità
storica bisogna sottolineare che, se da una parte si osannava all’Impero,
dall’altra il grosso pubblico fu deluso: si aspettava che dalle acque
emergessere chissà quali tesori. Questo scontento latente e le
mancate aspettative a riguardo hanno una eco anche in Senato, dove, nella
seduta dell’8 giugno 1929, il Ministro della Pubblica Istruzione
Giuseppe Belluzzo afferma: "Il lago di Nemi, il cui livello è
stato abbassato di circa 7 metri, ha restituito alla luce del sole una
parte delle prima nave in condizioni tali da restare ancora una volta
confermato che la terra e l’acqua sono più gelosi conservatori
dell’uomo. C’è qualcuno che davanti a quel che rimane
della prima nave affondata circa 19 secoli fa, si domanda se valeva la
pena di compiere un così enorme lavoro di recupero. Onorevoli Senatori,
consentitemi di rispondere a quel qualcuno e a tutti i dubbiosi: sì,
valeva la pena. Se anche le spese e gli sforzi avessero dovuto essere
maggiori, sarebbe comunque valsa la pena." E poi, ancora: "Qualche
ingenuo attendeva forse di ritrovare la nave intatta nelle sue strutture
e con tutti i suoi ornamenti, e si sente oggi deluso; ma quelli che conoscono
le vicende due volte millenarie delle navi di Caligola dichiarano che
la realtà supera le speranze, e che il rapporto fra lo stato attuale
e quello originale della nave scoperta è di gran lunga superiore
al rapporto tra lo stato attuale e quello originale del Foro Romano. E
c’è poi un immenso interesse tecnico giacché la nave
recuperata ci appalesa a quale perfezione ed a quali virtuosismi fosse
pervenuta, presso i Romani, l’arte del costruire navi di legno".
Gli oggetti rinvenuti a bordo vengono momentaneamente custoditi in
una baracca, e sono: alcune fistole di piombo; un rubinetto funzionante
- che diverrà, per la sua tecnica che potremmo definire moderna,
uno dei più famosi ed ammirati reperti; una testa di lupo in bronzo,
in parte ancora dorata, che luccicava al sole e che porta un anello stretto
fra i denti; numerosi tubi di piombo e di bronzo, cerniere; una gran quantità
di chiodi di ferro, di bronzo e di rame, della cui speciale tecnica d’impiego
si tratterà in seguito; un gran numero di chiodini dalla testa
dorata simili alle moderne puntine da disegno; grandi tegole di rame dorato
e lastre di cotto a forma trapezoidale cogli orli dei lati maggiori rialzati,
chiamate embrici ed usate come tegole; molti fogli di piombo sottilissimi
che servivano a coprire la chiglia con uno scopo che sarà spiegato
più avanti; alcune bellissime teste di felino. Il 7 novembre
1929 improvvisamente tutta la zona intorno alla nave si sfalda e s’abbassa
scivolando alquanto nel lago. Diminuendo il livello, la pressione dell’acqua
sulle pareti era diminuita, e così la crosta superficiale, ormai
disseccata al sole, era scivolata sulla parte sottostante, ancora allo
stato semiliquido. I visitatori, numerosi come tutti i giorni, sono
presi dallo spavento sentendosi sfuggire la terra sotto i piedi, e salgono
in fretta sulla nave per mettersi al sicuro; ma il fenomeno è di
breve durata. Tutto si riassetta di nuovo ed i lavori possono riprendere
con rinnovata lena. aspiravano
le acque e le immettevano nella galleria dell’emissario ormai liberato
dalle rocce e sedimenti che lo avevano parzialmente ostruito. Molti di
quei testimoni scrissero la loro emozione al vedere le acque uscire dalla
terra e correre verso il mare. Infine si era giunti, dopo speranze, dubbi
ed un durissimo lavoro, alla certezza che l’opera avrebbe, finalmente,
potuto realizzarsi; che la si stava già realizzando. Il 16
ottobre si verificò una leggera scossa tellurica, quasi che la
natura si risvegliasse avvertendo gli uomini che, nonostante i lavori
nel suo seno, le dovessero rispetto e qualcuno temé... un sinistro
preavviso. Si dette incarico all’Osservatorio Geofisico di Rocca
Di Papa, così vicino al Lago di Nemi, di tenere sotto controllo
il territorio al fine di comunicare eventuali, ulteriori scosse. Fortunatamente,
però, il sisma era locale e non se ne verificarono altri. Si poté,
così, iniziare lo svaso del lago ed il 20 ottobre 1928 Mussolini,
accompagnato dal Sottosegretario agli Interni e dai Ministri della Pubblica
Istruzione e dei Lavori Pubblici, mise in funzione l’impianto idrovoro.
La grande impresa, finalmente, iniziava. Quattro grossi tubi aspiravano
l’acqua del lago e la gettavano nell’emissario. Dell’avvenimento
si parlò in tutto il mondo e tutto il mondo volse lo sguardo verso
Roma. È impossibile far cenno dell’ammirazione\invidia che
generò l’impresa. Nessun altro aveva due grandi ed antiche
navi romane da riportare alla luce, e pochi avrebbero avuto le capacità
di farlo in maniera degna. Le grandi pompe idrovore lavoravano quasi in
silenzio facendo abbassare il livello del lago in modo continuo anche
se quasi impercettibile. Le acque venivano convogliate nell’antico
emissario e, attraverso l’Ariccia, giungevano fino al mare. Ma l’opera
non poteva limitarsi al solo abbassamento del livello del lago di Nemi.
Molti altri problemi dovevano essere affrontati e risolti. A tal fine
si riunì la Commissione Nemorense che era stata nominata
dal Ministro per l’Educazione Nazionale, Giuseppe Belluzzo, della
quale facevano parte il sen.Corrado Ricci, l’ing.Malfatti, l’ing.Biagini
ed altri. Tale commissione decise la costruzione di una strada che doveva
unire la città di Genzano al Lago. Inoltre pose le basi per la
soluzione di altri problemi ugualmente necessari ed urgenti: provvedere
alla costruzione di un riparo provvisorio per le due navi nonché
tutti gli oggetti antichi che si sarebbero trovati e, successivamente,
ad edificare un museo definitivo che potesse degnamente accogliere il
tutto. È il caso di sottolineare che il Museo delle navi in questione
sarà un’opera fatta "ad hoc", nel senso che è
uno dei pochi ad essere stato costruito per ospitare uno specifico reperto.
Altro problema che la commissione Nemorense doveva affrontare e risolvere
era la tutela della splendida corona vegetale che arricchiva le sponde
del Lago di Nemi. Per la sua conservazione venne, addirittura, licenziata
una legge a carattere paesaggistico che tutelava quell’ornamento
arboreo dichiarando di pubblica utilità quei magnifici boschi.
Il Genio Civile, che per ordine del Consiglio dei Ministri costruiva la
strada che va da Genzano al lago, si trovò ad affiancare parte
di un’antica strada romana che si dipartiva dalla Via Appia e prendeva
il nome di Via Virbia o Clivus Aricinus, lastricata con
la tipica pavimentazione a lastroni a basole. Il nome di Viribio sembra
derivi da vir e bios , dove vir originerebbe da virae,
ossia dal nome delle ninfe degli alberi, che unito a bios prenderebbe
il significato di vita vegetale, ovvero designerebbe una divinità
campestre. Ebbene, questa strada si dirigeva all’Artemisio, da dove
la Via dei Trionfi saliva al Tempio di Giove Laziale su quello che, oggi,
si chiama Monte Cavo. Ma torniamo alle navi. Il 28 marzo 1929 affiorarono
le più alte strutture della prima nave. I giornali e le radio di
tutto il mondo fanno da eco all’importante ritrovamento ed ancora
una volta il nome di Roma vola sulle ali del vento. La notizia viene immediatamente
data dal Capo del Governo col seguente rapporto: "Oggi hanno cominciato
ad affiorare i resti della parte poppiera della prima nave, di quella
parte, cioè, che, per essersi trovata a minore profondità
sotto il livello del lago, è stata più fortemente danneggiata
dai tentativi di recupero compiuti nei secoli scorsi. Trattasi, per ora,
di alcune travi e tavoloni rivestiti, questi ultimi, di lamierino di piombo,
tuttora ben consistenti e fra loro connessi, dai quali spiccano lunghi
chiodi che congiungevano le strutture rimaste con quelle strappate ed
asportate anticamente. Ad acque chiare e tranquille ed a luce propizia,
il che si verifica specialmente nelle ore del mattino, è dato di
scorgere altre strutture, emergenti qua e là dal limo che le ricopre,
il cui andamento lascia intravedere la maggiore ampiezza che assume la
mole man mano che scende in profondità". Finalmente
emerge la nave più vicina alla riva. Quella che giaceva ad una
profondità minore e che, essendo recuperata per prima, sarà
d’ora in poi chiamata prima nave. Oltre alle numerose
fotografie che furono fatte allo scafo, da tutte le angolazioni; oltre
alle foto scattate ai numerosi reperti che vi si trovavano sopra, siamo
in possesso anche di un’accuratissima relazione dell’esplorazione
della parte emersa della nave, stilata prima ancora di procedere alla
rimozione dei reperti stessi. Tale relazione la dobbiamo al prof. Cultrera,
Sovrintendente dell’epoca, che il 1° maggio del 1929 dette inizio
ad una rigorosa serie di rilievi, di osservazioni e di fotografie che
furono la base di partenza di tutti i successivi attenti studi di archeologia
marina. L’importanza di quell’opera sta nell’aver fissato
nel tempo il momento in cui la nave emergeva dalle acque per effetto dell’abbassamento
del livello del lago. Quel momento era irripetibile, ed era quindi necessario
documentarlo con la massima precisione. Come uno sciame di api attornia
l’alveare, così la nave romana del lago di Nemi richiama un’immensa
folla di visitatori attratti dall’eccezionalità dell’evento,
fra i quali i giornalisti stranieri invitati dallo stesso Ministro della
Pubblica Istruzione. Costoro, di fronte ad una nave di 2000 anni riportata
alla luce del sole, scriveranno innumerevoli ed importanti articoli sull’argomento,
esaltando la civiltà dell’antica Roma (e la bravura di quella
moderna). Pochi giorni dopo, l’ing.Vittorio Malfatti - l’ufficiale
del Genio Navale che, avvalendosi di un esperto palombaro, aveva compiuto
accuratissime esplorazioni, diligenti accertamenti, importanti rilievi
e studi sulle navi - ha la grande soddisfazione di guidare un folto gruppo
di tecnici d’alto livello a visitare lo scafo da poco emerso. Di
tale gruppo fanno parte i congressisti della Insitution of naval architects,
alcuni Ammiragli della Real Marina inglese, ed ingegneri dell’industria
navale britannica. Tutti costoro sfilano davanti alla nave ammirandola
in ogni particolare, attenti alle spiegazioni dell’ing. Malfatti;
ed affermano che questa impresa dona alla cultura mondiale un enorme contributo
di conoscenza, unendo così la loro voce autorevole a quella dei
giornalisti della stampa estera, che poco prima avevano narrato l’eccezionale
evento sui quotidiani di tutto il mondo. Quei signori, giustamente orgogliosi
di far parte della Marina più importante di allora, sia dal lato
qualitativo che quantitativo, ebbero molto a meravigliarsi che alcune
soluzioni tecniche ritenute di loro invenzione fossero già conosciute
ed usate dai romani 2000 anni prima. Di tali ritrovati tratteremo nell’ultima
parte, quando parleremo del museo. C’è un aspetto che,
crediamo, non debba sfuggire a chi desideri ripercorrere quegli anni se
vuol cogliere appieno il significato e le ragioni di tutta l’impresa.
In Italia in quel periodo c’era una forte rivalutazione della Roma
antica, e gli atti politici erano spinti dal desiderio di ripercorrerne
in qualche modo la storia, cercando di eguagliarne il cammino. Si volle
conquistare un impero, si vollero ingrandire i confini d’Italia,
si volle, tra le altre cose, riportare alla luce quelle due antiche navi.
Certamente la democrazia ha i suoi difetti, ma non crediamo che vi sia
una forma migliore di governo. Dato per scontato questo - e resti ben
chiaro - la dittatura a modesto avviso dello scrivente ha almeno la caratteristica
di dare esecuzione immediata alla volontà di chi è al potere.
In regime democratico si discute, si mette ai voti, si replica, si soppesa...
le decisioni sono valutate e ponderate, ma il tempo passa e a volte i
problemi hanno troppo lenta soluzione. Al contrario, un regime dittatoriale
non ammette possibilità di discussione. La volontà è
una, e basta. Quel che si vuole fare, viene subito fatto. Quando va male...
va male. Ma stavolta andò bene. Ecco spiegato perché il
recupero delle navi vi fu proprio in quel periodo. Non solo perché
era possibile disporre finalmente di potenti pompe idrovore; ma perché
quell’impresa faceva parte della politica generale del momento. Ed
ecco perché l’ing. Malfatti volle e poté condurre personalmente,
in veste di cicerone, quei tecnici d’alto livello e quegli Ammiragli
inglesi a visitare ed ammirare quella vittoria archeologica. Ed ecce perché
il Ministro della Pubblica Istruzione volle e poté invitare i rappresentanti
della stampa estera. Gli studiosi e gli archeologi che da tanti anni si
occupavano di quelle vestigia seppero cogliere il momento politico ed
offrirono la loro collaborazione entusiasta. Molte aziende dettero gratuitamente
il loro apporto tecnico, e tutte queste energie convergenti... salvarono
le navi. Peccato che agli uomini non sia dato di guardare, nemmeno
un poco, nel loro futuro. Se lo avessero potuto... forse avrebbero lasciato
le navi dov’erano. Questo però nulla toglie all’eccezionale
grandiosità dell’opera; è solo il triste commento di
chi scrive pensando al drammatico destino cui le navi andarono incontro.
Si istituì un libro dei visitatori sul quale si possono ancora
leggere gli autografi dei personaggi allora più in vista, cominciando
dalla famiglia reale e via via continuando con reali di altri Stati, ministri,
scienziati, studiosi, e molte altre persone più o meno importanti
che vollero vedere l’antico reperto. Per dovere di verità
storica bisogna sottolineare che, se da una parte si osannava all’Impero,
dall’altra il grosso pubblico fu deluso: si aspettava che dalle acque
emergessere chissà quali tesori. Questo scontento latente e le
mancate aspettative a riguardo hanno una eco anche in Senato, dove, nella
seduta dell’8 giugno 1929, il Ministro della Pubblica Istruzione
Giuseppe Belluzzo afferma: "Il lago di Nemi, il cui livello è
stato abbassato di circa 7 metri, ha restituito alla luce del sole una
parte delle prima nave in condizioni tali da restare ancora una volta
confermato che la terra e l’acqua sono più gelosi conservatori
dell’uomo. C’è qualcuno che davanti a quel che rimane
della prima nave affondata circa 19 secoli fa, si domanda se valeva la
pena di compiere un così enorme lavoro di recupero. Onorevoli Senatori,
consentitemi di rispondere a quel qualcuno e a tutti i dubbiosi: sì,
valeva la pena. Se anche le spese e gli sforzi avessero dovuto essere
maggiori, sarebbe comunque valsa la pena." E poi, ancora: "Qualche
ingenuo attendeva forse di ritrovare la nave intatta nelle sue strutture
e con tutti i suoi ornamenti, e si sente oggi deluso; ma quelli che conoscono
le vicende due volte millenarie delle navi di Caligola dichiarano che
la realtà supera le speranze, e che il rapporto fra lo stato attuale
e quello originale della nave scoperta è di gran lunga superiore
al rapporto tra lo stato attuale e quello originale del Foro Romano. E
c’è poi un immenso interesse tecnico giacché la nave
recuperata ci appalesa a quale perfezione ed a quali virtuosismi fosse
pervenuta, presso i Romani, l’arte del costruire navi di legno".
Gli oggetti rinvenuti a bordo vengono momentaneamente custoditi in
una baracca, e sono: alcune fistole di piombo; un rubinetto funzionante
- che diverrà, per la sua tecnica che potremmo definire moderna,
uno dei più famosi ed ammirati reperti; una testa di lupo in bronzo,
in parte ancora dorata, che luccicava al sole e che porta un anello stretto
fra i denti; numerosi tubi di piombo e di bronzo, cerniere; una gran quantità
di chiodi di ferro, di bronzo e di rame, della cui speciale tecnica d’impiego
si tratterà in seguito; un gran numero di chiodini dalla testa
dorata simili alle moderne puntine da disegno; grandi tegole di rame dorato
e lastre di cotto a forma trapezoidale cogli orli dei lati maggiori rialzati,
chiamate embrici ed usate come tegole; molti fogli di piombo sottilissimi
che servivano a coprire la chiglia con uno scopo che sarà spiegato
più avanti; alcune bellissime teste di felino. Il 7 novembre
1929 improvvisamente tutta la zona intorno alla nave si sfalda e s’abbassa
scivolando alquanto nel lago. Diminuendo il livello, la pressione dell’acqua
sulle pareti era diminuita, e così la crosta superficiale, ormai
disseccata al sole, era scivolata sulla parte sottostante, ancora allo
stato semiliquido. I visitatori, numerosi come tutti i giorni, sono
presi dallo spavento sentendosi sfuggire la terra sotto i piedi, e salgono
in fretta sulla nave per mettersi al sicuro; ma il fenomeno è di
breve durata. Tutto si riassetta di nuovo ed i lavori possono riprendere
con rinnovata lena.
Il salvataggio. La distruzione.
La prima nave, strappata alle acque del lago, è ora al riparo
sotto un capannone nell’attesa che sia costruito un museo che possa
degnamente accoglierla, insieme ai reperti che le sono stati trovati sopra
ed intorno.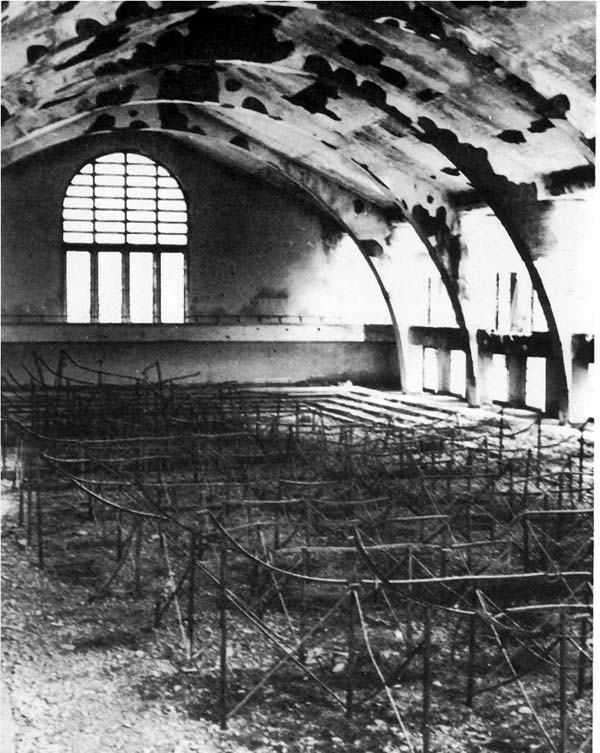 A questo punto nascono due correnti di pensiero. Alcuni sono contrari
al salvataggio anche della seconda nave; altri invece pensano che si debba
recuperare anch’essa. I primi adducono a ragione delle loro perplessità
il fatto che le strutture della nave che è ancora sott’acqua
sono identiche a quelle del natante che è già stato tratto
a riva, e i reperti che si troverebbero, sempre che se ne trovassero,
sarebbero certamente del tutto simili a quelli già rinvenuti sopra
ed attorno alla prima nave; quindi sarebbero inutili sia le spese sia
le fatiche. I secondi, invece, sono dell’avviso che si debba trarre
fuori delle acque anche l’altra imbarcazione. Essi affermano che,
in ogni caso, spese e fatiche sarebbero ampiamente giustificate dall’importanza
di ciò che sta ancora sotto il Lago di Nemi. Prevalse la seconda
tesi: anche l’altra nave fu tratta a riva ed entrambe trovarono posto
nel Museo delle Navi Romane che possiamo ancora ammirare. Purtroppo possiamo
ammirare solo il museo e non più le navi per le ragioni che saranno
narrate tra poco. Il museo, maestoso anch’esso, le conservò
entrambe. Alzando gli occhi ad osservarne l’altissimo tetto, sembra
che questo abbia la forma di un’enorme imbarcazione rovesciata dalla
quale si possa ammirare il fasciame, in alto, sopra le nostre teste. Anche
i numerosi reperti trovarono posto accanto alle due antiche navi. Leoni
e pantere di bronzo guardavano il turista incutendogli rispetto e destandone
meraviglia ad un tempo. Antichissimi macchinari che, nella loro modernità,
ci stupiscono e che credevamo frutto di scienza recente, erano, invece,
il risultato di una tecnica millenaria. Ed il turista, e anche lo studioso,
anzi soprattutto lo studioso, si aggirava fra tutti quegli oggetti che
erano risorti a nuova vita con quell’ammirata meraviglia piena di
rispetto per una civiltà che aveva forgiato il mondo antico e risplendeva
ancora in quello di oggi. I secoli passati scorrevano lenti di fronte
a chi aveva la ventura di poterli osservare nel loro lento incedere maestoso.
Nel loro muto linguaggio parlavano a chi sapeva ascoltarlo. Per i millenni
futuri, alle future generazioni. Ma venne il fuoco. Tutto avvampò
nelle fiamme: le belle navi, i tanti oggetti antichi, la loro storia.
Perché? Correva l’anno 1944 e c’era la seconda
guerra mondiale. La notte tra il 31 maggio e il 1 giugno le fiamme rischiararono
il Lago di Nemi. Bombardamento? Cannoneggiamento? Scintille sfuggite ai
fornelli degli sfollati che, riparatisi nel museo, cuocevano il desinare
sotto le navi? Atto vandalico delle truppe tedesche in ritirata? Non si
seppe mai, con certezza, il perché di quelle fiamme. Tutto andò
distrutto. Si salvarono solo quei reperti che erano stati, precedentemente,
trasportati nel Museo Nazionale Romano, proprio per essere più
sicuramente conservati. Ora quel che resta, quel che si è salvato,
è stato ricomposto alla venerazione dei visitatori e degli studiosi.
Le due navi sono state riprodotte in scala 1/5, e questi modellini sono,
l’uno dietro l’altro, esposti in un’ala del museo, bastandone,
purtroppo, una sola a contenerli entrambi. Quel che resta, però,
è ancora sufficiente a stupire il visitatore. Nel prossimo
capitolo, che sarà l’ultimo, saranno esaminati nella forma
e descritti nell’utilizzo tutti i reperti ora esposti.
A questo punto nascono due correnti di pensiero. Alcuni sono contrari
al salvataggio anche della seconda nave; altri invece pensano che si debba
recuperare anch’essa. I primi adducono a ragione delle loro perplessità
il fatto che le strutture della nave che è ancora sott’acqua
sono identiche a quelle del natante che è già stato tratto
a riva, e i reperti che si troverebbero, sempre che se ne trovassero,
sarebbero certamente del tutto simili a quelli già rinvenuti sopra
ed attorno alla prima nave; quindi sarebbero inutili sia le spese sia
le fatiche. I secondi, invece, sono dell’avviso che si debba trarre
fuori delle acque anche l’altra imbarcazione. Essi affermano che,
in ogni caso, spese e fatiche sarebbero ampiamente giustificate dall’importanza
di ciò che sta ancora sotto il Lago di Nemi. Prevalse la seconda
tesi: anche l’altra nave fu tratta a riva ed entrambe trovarono posto
nel Museo delle Navi Romane che possiamo ancora ammirare. Purtroppo possiamo
ammirare solo il museo e non più le navi per le ragioni che saranno
narrate tra poco. Il museo, maestoso anch’esso, le conservò
entrambe. Alzando gli occhi ad osservarne l’altissimo tetto, sembra
che questo abbia la forma di un’enorme imbarcazione rovesciata dalla
quale si possa ammirare il fasciame, in alto, sopra le nostre teste. Anche
i numerosi reperti trovarono posto accanto alle due antiche navi. Leoni
e pantere di bronzo guardavano il turista incutendogli rispetto e destandone
meraviglia ad un tempo. Antichissimi macchinari che, nella loro modernità,
ci stupiscono e che credevamo frutto di scienza recente, erano, invece,
il risultato di una tecnica millenaria. Ed il turista, e anche lo studioso,
anzi soprattutto lo studioso, si aggirava fra tutti quegli oggetti che
erano risorti a nuova vita con quell’ammirata meraviglia piena di
rispetto per una civiltà che aveva forgiato il mondo antico e risplendeva
ancora in quello di oggi. I secoli passati scorrevano lenti di fronte
a chi aveva la ventura di poterli osservare nel loro lento incedere maestoso.
Nel loro muto linguaggio parlavano a chi sapeva ascoltarlo. Per i millenni
futuri, alle future generazioni. Ma venne il fuoco. Tutto avvampò
nelle fiamme: le belle navi, i tanti oggetti antichi, la loro storia.
Perché? Correva l’anno 1944 e c’era la seconda
guerra mondiale. La notte tra il 31 maggio e il 1 giugno le fiamme rischiararono
il Lago di Nemi. Bombardamento? Cannoneggiamento? Scintille sfuggite ai
fornelli degli sfollati che, riparatisi nel museo, cuocevano il desinare
sotto le navi? Atto vandalico delle truppe tedesche in ritirata? Non si
seppe mai, con certezza, il perché di quelle fiamme. Tutto andò
distrutto. Si salvarono solo quei reperti che erano stati, precedentemente,
trasportati nel Museo Nazionale Romano, proprio per essere più
sicuramente conservati. Ora quel che resta, quel che si è salvato,
è stato ricomposto alla venerazione dei visitatori e degli studiosi.
Le due navi sono state riprodotte in scala 1/5, e questi modellini sono,
l’uno dietro l’altro, esposti in un’ala del museo, bastandone,
purtroppo, una sola a contenerli entrambi. Quel che resta, però,
è ancora sufficiente a stupire il visitatore. Nel prossimo
capitolo, che sarà l’ultimo, saranno esaminati nella forma
e descritti nell’utilizzo tutti i reperti ora esposti.
Il museo
Il nostro viaggio sulle navi di Caligola volge, ormai, al
termine. Le grandi opere, le fatiche, le illusioni, la pazza volontà
dell’imperatore, la storia millenaria, l’esaltante recupero,
il flagello del fuoco che le ha distrutte, tutto è passato. Rimane
un grande museo quasi vuoto. Tuttavia, nonostante quel che resta sia molto
meno di quel che c’era, può ancora interessare il visitatore,
specialmente se è guidato passo passo in questo viaggio nella storia
da qualcuno che sappia illustrargli ciò che vede e raccontargli
ciò che fu. Nella navata di sinistra vi sono due modelli, scala
1/5, delle navi andate distrutte dalle fiamme. I legni usati per la costruzione
di quelle furono la "Quercus sessiflora", la "Quercus peduncolata" ed
il "Pinus halepensis". Le analisi del legno (dette paleobotaniche, perché
effettuate su legni antichi) hanno evidenziato un uso dei legni adeguato
alle esigenze costruttive, con l’impiego di specie diverse e persino
di parti diverse della pianta in relazione alle funzioni che dovevano
avere. Per il fasciame, per il quale era necessario un legno dolce, fu
usato il pino; mentre per la costruzione del ponte venne scelto il legno
di quercia. Anche il taglio delle travi venne eseguito in modo da permettere
la massima resistenza. La carena era spalmata con minio di ferro,
ed era impermeabilizzata con un rivestimento di lana impregnata di una
miscela di pece vegetale, di bitume e di colofonia su cui erano applicate,
con chiodini di rame, lamine di piombo spesse un millimetro e lunghe m.l,40.
Questo rivestimento era un’ottima difesa contro gli attacchi dei
molluschi "xilofagi" (mangiatori di legno), e precisamente di teredine,
un mollusco che si trova nelle acque del mare. Il suo corpo é vermiforme
e quasi trasparente, protetto da due valve lunghe 8-9 millimetri che gli
proteggono la testa. Quando è ancora allo stato di larva questo
mollusco si fissa a tutti gli oggetti di legno che sono sommersi ed usa
le valve come due piccole pale per scavarvi delle gallerie che possono
arrivare fino a 30 cm. Allo stesso tempo ne riveste le pareti con un sottile
strato calcareo. È chiaro che se un’imbarcazione è
aggredita da un grande numero di teredini, la chiglia ne é gravemente
danneggiata fino alla linea di galleggiamento. A questo punto dobbiamo
sottolineare che i romani conoscevano sia il mollusco che i danni che
provocava e, soprattutto, come lo si dovesse neutralizzare. Per un popolo
di pastori.... Ci si domanda, però, perché si fosse usato
questo rivestimento e tutti quegli accorgimenti or ora descritti nel caso
delle navi di Nemi. Il lago non è il mare e la teredine è
un mollusco di acqua salata. Perfezionismo d’altri tempi ed amore
del particolare anche se superfluo, oppure paura dell’ira di Caligola
che pretendeva la perfezione? Non lo sapremo mai. Continuiamo a parlare
dello studio cui furono sottoposti i due natanti: l’esame delle gomene
e delle salmastre ha rivelato che le prime furono fabbricate con fibre
di "sparto" (ossia ricavate dallo stelo o dalle foglie di una graminacea);
le seconde con fibre di canapa. Quanto ai collegamenti del fasciame, cioè
il sistema di costruire una trave collegando fra loro molte assi più
piccole fino ad ottenerne una della lunghezza voluta, erano fatti con
la tecnica detta "paparella", cioè ogni semitrave era dentata e
combaciava con le dentature della successiva, mentre il tutto era stretto
da sottili ma robuste fasce metalliche che le teneva unite fra loro. Per
quanto riguarda la chiusura del fasciame, era stata ottenuta sia a poppa
che a prua con la tecnica dell’unghia persa, che era ed è
il sistema di congiungere le tavole fra di loro in modo che convergano
in un solo punto a guisa di ventaglio. Il tutto, anche qui, era stretto
da fasce di metallo robuste e sottili. Si desidera sottolineare che, al
fine di non tediare il lettore con troppi particolari tecnici, è
descritta solo una minima parte delle avanzatissime soluzioni impiegate
nella costruzione delle due navi. Quanto alla seconda nave è da
segnalare l’interessante simmetria della poppa e della prua adottata
per poter andare nelle due direzioni, senza dover essere costretti a far
ruotare l’imbarcazione su se stessa. A tal fine alle estremità
vi erano quattro timoni per cambiare rapidamente direzione di rotta, avvalendosi
appunto dell’eguaglianza del disegno delle due estremità che
permetteva tale manovra nonostante le scarse dimensioni dello specchio
d’acqua. Addossato ad una parete, nella sinistra c’è
un pannello nel quale si possono ammirare vari esemplari di chiodi usati
sui due natanti: si sono salvati dall’incendio di quel triste giorno.
Hanno una grande varietà di dimensioni, forma ed uso. Da pochi
centimetri ad oltre mezzo metro, a sezione quadrangolare od a testa a
forma di piramide, con la sommità schiacciata e piccole protuberanze.
I materiali usati sono, per la maggior parte, il rame ed in misura minore
il bronzo ed il ferro. Dalle analisi micrografiche alle quali sono stati
sottoposti si evince la grande purezza, mentre l’alta percentuale
di rame usato rendeva i chiodi molto resistenti all’ossidazione.
Per evitare, inoltre, corrosioni e deformazioni del metallo, che il contatto
diretto con il legno di quercia poteva causare, i chiodi vennero incapsulati
in apposite "bussole" cilindriche di legno dolce come l’abete ed
il pino. Avviciniamoci, ora, all’antichissima ed autentica ancora
romana posta al centro della grande sala di sinistra: si è salvata
dal fuoco perché è di ferro ed è del tipo a "ceppo
mobile". Questo vuol dire che la metà superiore (simile ad una
grande T maiuscola) si poteva separare dal resto della struttura in modo
che questa fosse divisa in due parti. Una la si collocava a destra della
nave e l’altra a sinistra, con evidenti risultati di stabilità
durante la navigazione. Ed anche qui è d’uopo fare una precisazione
interessante. L’ancora a ceppo mobile, chiaramente inventata dai
romani, fu "riscoperta" nel secolo XIX dalla Marina inglese e, per tale
motivo, fu chiamata "ancora ammiragliato". La Marina italiana, dopo il
rinvenimento dell’ancora romana nel Lago di Nemi in data 20 maggio
1930 presso la riva in località Pizzo Raschiello, rivendicò
quell’invenzione e con una apposita circolare del gennaio 1938 dispose
che la si dovesse chiamare "ancora romana". Abbiamo detto che si era salvata
dal fuoco perché di ferro, ma bisogna precisare che era stretta
in una guaina di legno. Quella guaina andò perduta in quel triste
evento, ed è stata sostituita da un’altra perfettamente ricostruita.
Per completezza di informazione bisogna dire, inoltre, che sul ceppo mobile
vi è inciso il peso in libbre: 1275 (pari a Kg. 417). Presso l’ancora
della quale abbiamo trattato ne fu trovata un’altra recuperata il
27 ottobre 1930. Purtroppo non ebbe la stessa fortuna della precedente:
essendo di legno di quercia ed avendo il ceppo di piombo andò totalmente
distrutta ed ora ne possiamo ammirare solo una copia. Proseguiamo
la passeggiata nella storia ed osserviamo gli oggetti che sono esposti
intorno ai due modelli delle navi. Ci avviciniamo, così, ad
una "noria" cioè una pompa usata per vuotare la "sentina" della
nave, che è la parte più bassa nella quale si raccolgono
le acque che, nonostante ogni perfezione costruttiva, filtrano attraverso
la chiglia. Quella esposta nel museo è una ricostruzione
ridotta, resa possibile grazie al ritrovamento di una ruota dentata con
l’asse a sezione quadrata e di alcune boccole di bronzo. Si compone
di una serie di recipienti che, incernierati ad una catena verticale,
sono mossi da una manovella che, dando a tutto il complesso un movimento
dal basso verso l’alto, fa sì che si riempiano d’acqua
che viene espulsa quando, finita la corsa verticale, il recipiente si
dirige di nuovo verso il basso capovolgendosi. La visita al museo
prosegue: possiamo ammirare una pompa aspirante-premente avente lo stesso
scopo della noria che è stata descritta sopra. Di concezione
modernissima, è mossa da una leva a due bracci e si compone di
due stantuffi che salgono e scendono con movimento alterno e mentre uno
costringe l’acqua ad entrare da un lato, l’altro, con movimento
opposto, la espelle dall’altra parte. Purtroppo si tratta di una
ricostruzione, ma vicino c’è quel che resta dell’originale
dopo l’incendio. Uno dei pezzi più importanti e tecnicamente
evoluti, dal punto di vista della funzionalità, è la piattaforma
della gru ruotante, dallo studio della quale si evince a quale livello
di conoscenze scientifiche fossero pervenuti i costruttori navali dell’antica
Roma. Non solo conoscenza della meccanica, ma in questo caso anche delle
leggi della fisica, come l’attrito ed il calore che ne deriva, ed
il conseguente ingrossamento dei metalli che scorrono gli uni sugli altri,
nonché il relativo consumo di questi ed i mezzi idonei per eliminarlo,
o meglio per ridurlo. La piattaforma si compone di due dischi, uno sovrapposto
all’altro. Quello inferiore è fisso, mentre il superiore è
ruotante. Fra i due sono interposte delle sfere di metallo fissate mediante
staffe di ferro chiodate che, scaricando l’attrito su di un solo
punto, ne diminuiscono gli effetti frenanti. Insomma: è il cuscinetto
a sfere! È utile ricordare che i primi cuscinetti a sfere risalgono
al XVIII secolo, cioè a quando le nazioni più avanzate dal
punto di vista industriale dovettero risolvere problemi di dinamica meccanica.
Ebbene, il grande numero di tali sfere che sono state rinvenute sopra
ed attorno alle navi permette di ipotizzare la presenza di almeno quattro
di questi macchinari che servivano a sollevare grossi pesi. Analoghe piattaforme,
con identica utilizzazione, si dovevano servire dei rulli a forma di cono
in legno rinvenuti a prua della prima nave. Un disegno del Malfatti del
1895 testimonia la presenza di rulli a forma di cilindro in bronzo che
servivano, probabilmente, per trascinare grossi pesi, di cui purtroppo
non si è mantenuto alcun esemplare. Alla parete opposta a quella
d’entrata sono riunite in una rastrelliera alcune fistulae aquariae.
Sono dei tubi di piombo ottenuti saldando fogli di questo metallo. Servivano
a convogliare l’acqua dalle rive del lago fin sulle navi. Portano
impresso sul fianco il nome di chi le volle. Su quei tubi è inciso:
Caesaris Aug Germanici, cioè Caligola. In conseguenza di
ciò fu facile collocarle nel tempo: furono costruite nel periodo
37-41 d.C. In una vetrina sono esposte parti di opus sectile con
lastre di serpentino e porfido utilizzate per le decorazioni dei pavimenti
(le più spesse) e delle pareti (le più sottili). Ed ancora
vi sono esposte strisce di pasta vitrea bianca, rossa e verde, lavorata
a bacchetta, utilizzate nei mosaici come motivo decorativo associato all’opus
sectile ed al tessellatum. In entrambi i saloni che contenevano
le due navi è visibile un tratto della strada basolata (dalla pietra
usata per le costruzioni stradali antiche) che alla altezza di Cynthianum,
l’odierna Genzano, si distaccava dalla Via Appia per condurre al
Santuario di Diana. Tale strada fu rinvenuta durante gli scavi per la
costruzione del Museo delle Navi. All’entrata di questo si può
ammirare il calco della statua bronzea di Diana o di Drusilla (sorella
di Caligola) in atteggiamento di sacerdotessa. L’originale recuperato
nel lago nell’anno 1895, insieme ad altre sette statuine di minori
dimensioni, rappresentanti genii e sacerdotesse, è ora esposto
al British Museum di Londra. Accanto, o meglio un poco prima di queste
statuine, sempre all’entrata del museo, v’è una colonnina
tortile in pavonazzetto, con capitello corinzio rinvenuta presso la seconda
nave. Vicino ad essa una base marmorea proveniente anch’essa dalla
seconda nave dimostra, essendo piuttosto di grandi dimensioni, quanto
grande dovesse essere anche la relativa colonna. E torniamo all’interno.
Due frammenti di pavimento a mosaico realizzati con la tecnica mista
dell’opus sectile in porfido e serpentino, dell’opus
tessellatum in palombino e dell'opus vermiculatum in pasta
vitrea lavorata a bacchetta. Entrambi provengono dalle ricerche condotte
sulla prima nave per conto di Eliseo Borghi nell’anno 1895. Per descrivere
le numerose cerniere di bronzo, di varie dimensioni, usate per gli infissi
delle due navi, bastano due parole: moderne e perfette. Facciamo, quindi,
cenno ai numerosi laterizi rinvenuti soprattutto a bordo della prima nave:
tuboli cilindrici usati per sostenere il tavolato del ponte che, incastrati
in coppia, formavano un’intercapedine tra questo e lo scafo. E poi
tuboli a sezione rettangolare usati per il riscaldamento. Infine un mattone
bipedale armato con barre di ferro, su alcune delle quali è impressa
una C (Caesar), forse utilizzato nei forni. Finalmente siamo
arrivati a descrivere tutti i più importanti reperti custoditi
nel Museo delle Navi. Un pensiero, a questo punto, sfiora la mente di
chi ha la ventura di osservarli: se questi erano gli oggetti che furono
affondati con le due navi nelle acque del Lago di Nemi a seguito della
decretata damnatio memoriae, dobbiamo supporre che i romani non
vi annettessero grande importanza. Questo sta a quantificare il valore
aggiunto dalla Storia a questi reperti antichi, malgrado non siano né
d’oro né d’argento, ma di bronzo, d’argilla, di
legno. Le navi, più che imbarcazioni, erano grossi natanti
riccamente addobbati sui quali l’imperatore amava dare feste e ricevimenti
secondo un’usanza molto diffusa durante l’Impero. Sappiamo che
Domiziano dava ricchissimi ricevimenti nella sua grandiosa villa sul Lago
Albano. Tacito ricorda l’uso di Tigellino, prefetto di Nerone, di
offrire cene su grosse zattere trainate da barche nello Stagno di Agrippina,
un bacino in parte artificiale nel Campo Marzio a Roma. Svetonio racconta
che Caligola "fece costruire navi liburniche a dieci ordini di
remi con le poppe coperte di gemme, vele policrome, con terme, portici,
triclini di grande ampiezza e addirittura con una grande varietà
di viti e di alberi da frutta. E su queste soleva navigare standosene
sdraiato tutto il giorno lungo le rive della Campania tra danze e musiche".
Queste descrizioni, pur trattandosi di altre imbarcazioni, potrebbero
valere anche per le due navi di Nemi; per quanto vi siano studiosi che
preferiscano identificarle con santuari galleggianti collegati al vicino
Tempio di Diana. Il Museo delle Navi Romane del Lago di Nemi è
mèta di turisti. Entrano, guardano, s’interessano molto ai
numerosi reperti, seguono le spiegazioni di tutto ciò che concerne
le navi, ma rimangono delusi quando vengono a sapere che sono andate distrutte
e che quelli esposti non sono che modelli in scala 1/5. Per cercare di
ovviare a questo, un piccolo gruppo di cittadini sensibili ed amanti delle
antiche cose s’è fatto promotore di un’associazione per
la ricostruzione di almeno una delle due navi a grandezza naturale. È
stata costituita a tal fine l’Associazione Dianae Lacus l’11
dicembre 1995, alla quale successivamente si sono affiancati vari enti,
pubblici, privati e di amministrazione locale. Insieme hanno cercato e
trovato alcuni sponsor anch’essi sensibili alla storia di Roma. È
stata così costruita, dinanzi al Museo delle Navi, una struttura
prodiera alta e snella che si staglia verso il cielo e riproduce il profilo
della prima nave dalla ruota di poppa a quella di prua. Speriamo di vederla,
presto, completa. Il primo millennio ha visto le navi nascere ed affogare
sott’acqua. Il secondo millennio le ha viste bruciare. Speriamo sinceramente
che il terzo ne vedrà rinascere almeno una, ad eguagliare la mitica
Fenice. Ce lo auguriamo tutti. Buon lavoro, Associazione Dianae
Lacus! Massimo e Marina Medici |
 Le navi di Nemi
Le navi di Nemi